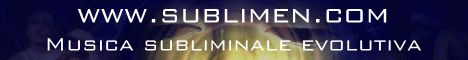|
admin
Webmaster
    
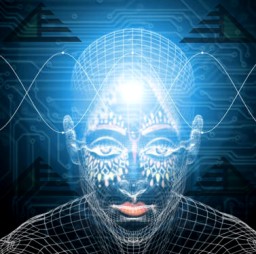
Regione: Italy
Prov.: Pisa
Città: Capannoli

24917 Messaggi |
 Inserito il - 26/12/2004 : 11:51:24 Inserito il - 26/12/2004 : 11:51:24


|
Il fumo passivo è nocivo
R.S. A cura di Anna Ermanni - ecplanet.net
Non ci sono “ma” che tengano. Il fumo passivo è un potente cancerogeno. La nuova monografia sulle sostanze cancerogene, messa a punto dall'International Agency for Research on Cancer (AIRC) di Lione, la principale istituzione europea che si occupa di ambiente e di cancro, lo colloca nel Gruppo 1 della classifica, vale a dire tra le molecole che hanno dimostrato di avere una inconfutabile relazione causa-effetto tra l'esposizione ai suoi componenti e la comparsa di tumori nell'essere umano. A sostenere per primo questo legame è stato tuttavia Richard Doll con un articolo pubblicato sul British Medical Journal nel 1950.
Da allora una copiosa letteratura scientifica ha prodotto una grande quantità di dati sulla pericolosità di questo nemico invisibile. Ora un folto gruppo di esperti riunito dall'AIRC ha addirittura esaminato più di 50 studi eseguiti in molti Paesi volti a valutare il rapporto tra il fumo passivo e il rischio di tumore del polmone nei non-fumatori. L'analisi unificata dei dati ha messo in evidenza un significativo aumento di tale rischio nei coniugi non-fumatori esposti al fumo del partner. «Nei mariti è arrivato al 20 per cento, mentre nelle mogli al 30 per cento», dice Annie J. Casco, direttrice dell'Unità di Epidemiologia per la prevenzione del cancro dello IARC di Lione. «In modo analogo nelle persone che respirano il fumo passivo sul posto di lavoro il rischio di cancro del polmone lievita del 16-19 per cento.
LE PRINCIPALI SOSTANZE TOSSICHE CANCEROGENE NEL FUMO DI SIGARETTE
SOSTANZE SOLIDE PRESENTI NELLE POLVERI:
anatabine, fenoli, catecoli, anilina, 2-toluidina, 2-naftilammina, 4-aminobifenile, benzo(A)antracene, benzo(A)pirene, ybutirolactone, quinolina, cadmio, nickel, polonio 210, nitrosamine.
SOSTANZE GASSOSE:
monossido di carbonio (CO), ammoniaca, metilammina e dimetilammina, acido formico, acido acetico, ossidi di azoto, benzene, toluene, formaldeide, acroleina, " acetone, piridina, cianuro, idrazina, n-nitrosodimetilammina, 1.3-butadiene.
Esiste inoltre una relazione tra la dose di fumo a cui si è esposti e il rischio di contrarre il tumore polmonare che è comunque regolato dall'interazione geni-ambiente. È stato infatti dimostrato che certe sequenze di DNA aumentano il rischio di incorrere in queste neoplasie nei fumatori passivi. I soggetti costretti a sopportarlo hanno anche un rischio più elevato di incappare in altre patologie. Sono per esempio più predisposti ad ammalarsi di tumore dei seni nasali e ad avere una mortalità e morbilità maggiore per malattie cardiovascolari. Uno studio recentemente pubblicato su JAMA 2001; 286: 436-41 ha dimostrato come il fumo passivo sia in grado di provocare anche danni immediati. Un'esposizione di soli 30 minuti è capace di causare uno spasmo misurabile a livello delle arterie coronariche.
Le sostanze tossiche contenute nel fumo liberato dalla sigaretta sono inoltre in grado di elevare il rischio di polmoniti pneumococciche, della sindrome di morte improvvisa infantile e di morbilità generale respiratoria, nonché di incorrere in malattie cardiache e respiratorie. Le gestanti hanno inoltre qualche probabilità in più di partorire un bambino con un basso peso alla nascita. Anche la severità dell'asma infantile diminuisce quando i genitori riducono il fumo. In particolare uno studio svolto da Janson C. et al. e pubblicato su Lancet 2001; 358: 2103-09 ha dimostrato l'associazione esistente tra il fumo passivo e l'aumento dell'ipereattività bronchiale. I risultati di questo importante trial multicentrico europeo, che ha arruolato ben 7800 persone e ha coinvolto in Italia i centri di Torino, Verona e Pavia, sono i primi dati scientifici a favore di questa correlazione.
LE VIE ATTRAVERSO CUI AGISCE LA NICOTINA
La nicotina va considerata una droga e per quanto riguarda la capacità di indurre dipendenza va posizionata al primo posto dopo l'eroina, la cocaina e l'alcol. Benowitz l'aveva così classificata nel 1996. Agendo sul sistema dopaminergico, dà infatti piacere, gratificazione e benessere a chi l'assume. Quando la sua somministrazione cessa, si attiva il sistema noradrenergico, provocando insonnia, ansietà e un aumento dell'appetito. Il fumo di sigaretta causa anche altre modificazioni. Il monossido di carbonio che contiene si lega fortemente all'emoglobina, formando la carbossiemoglobina. Non si tratta tuttavia di un'associazione irreversibile. Se il paziente interrompe il suo vizio, questo legame viene meno nel giro di 2-3 giorni e i tessuti ritornano ad essere ben ossigenati.
Lo studio è stato infatti realizzato per valutare la prevalenza tra la popolazione degli individui esposti al fumo passivo e il nesso di quest'ultimo con la presenza di disturbi respiratori soggettivi, alterazioni dello stato funzionale respiratorio e le IgE totali sieriche. Per effettuare queste verifiche sono stati eseguiti un esame spirometrico e un test di provocazione bronchiale su oltre 5000 fumatori passivi. «Le conclusioni a cui gli autori sono giunti sono interessanti», dice Giovanni Invernizzi, responsabile nazionale della taskforce sul tabagismo della SIMG. «Innanzitutto è stato messo in evidenza come l'esposizione al fumo passivo sia molto variabile nelle diverse aree europee. Le città italiane si trovano tuttavia ai vertici della classifica con Pavia che presenta il 60 per cento di fumatori passivi. Il centro dove coloro che respirano i fumi altrui sono in percentuale più bassa e pari solo al 20 per cento, è invece Uppsala in Svezia».
È stato inoltre confermato che i sintomi respiratori sono significativamente più frequenti in chi è esposto a questo nemico invisibile e ad esso proporzionali. Più duratura è l'esposizione al fumo passivo più frequente è infatti l'insorgenza di tosse, sibili e dispnea. Non è stato invece osservato un aumento delle IgE nei fumatori passivi a differenza di quanto è riportato in altri studi. Questi risultati meritano alcuni commenti. Ribadiscono infatti su ampia scala come il fumo passivo sia un diffuso fattore di rischio per la salute dell'apparato respiratorio, come le comunità a bassa prevalenza di fumatori tra la popolazione facilitino probabilmente una legislazione più rigida sul divieto del fumo nei luoghi di lavoro e come il fumo passivo respirato sul lavoro sia apparentemente più dannoso di quello inalato in famiglia. A favore di quest'ultimo concetto è il comportamento più “attento” dei fumatori verso i propri familiari, rispetto ai colleghi, che vanno ad esempio ad accendere la sigaretta sul balcone o in locali separati.
il fumo passivo causa un eccesso di casi d'asma del 20 per cento nei bambini in età scolare che hanno i genitori fumatori. A sottolineare questo preoccupante risvolto è uno studio, pubblicato sull'Am. J. Resp. Crit. Care Med. 154: 681-688, 1996, ed eseguito da Ehrlich R.I. et al. su 1955 ragazzi con un'età compresa tra i 7 e i 9 anni che frequentavano 15 scuole di Cape Town. I risultati ottenuti hanno dimostrato una relazione diretta tra l'esposizione al fumo passivo, verificata con la presenza di cotinina nelle loro urine, e la comparsa di asma. I dati raccolti hanno inoltre indicato alcuni importanti fattori predisponenti l'iperreattività bronchiale. Oltre l'allergia ai pollini, la comparsa di eczemi e i genitori con asma, un importante determinante di questo disturbo respiratorio è il fumo della madre in gravidanza. Additare il fumo passivo come causa della comparsa di asma in un bambino non è sempre facile. I genitori che hanno il vizio della sigaretta negano spesso questa loro abitudine e disattendono i corsi informativi messi a punto su questa problematica. A denunciare questa tendenza è un'indagine, pubblicata sull'Am. J. Pubblic Health 86: 246-248, 1996, e svolta da Fish L. et al. del Department of Allergy and Immunology Group Health Inc di Minneapolis, che sottolinea come il 78 per cento delle famiglie in cui entrambi i genitori venivano intervistati non partecipava agli interventi educativi per ridurre il fumo passivo. Ma non solo. Il 17 per cento di esse negava addirittura che i propri bambini fossero asmatici, contro il 9 per cento delle famiglie di non fumatori.
Per il momento non è invece possibile affermare che il fumo passivo favorisca l'insorgenza del tumore alla mammella, mentre è probabile che i tumori pediatrici aumentino se la madre è stata esposta al fumo durante la gravidanza. Se il fumo passivo comporta un rischio neoplastico minore di quello attivo, è comunque un problema che interessa tuttavia molte persone. Il fumo passivo è più pericoloso di quanto si è soliti credere. Da più di 20 anni gli si riconosce un ruolo di inquinante indoor (Science 1980; 208: 464-72), in quanto contribuisce a incrementare il particolato fine disperso nell'aria. In generale il suo effetto si sottovaluta perché lo si considera un semplice gas. In realtà questo nemico invisibile è un aerosol di particelle solide piccolissime del diametro inferiore ai 10 micron (PM10) sospese in una miscela di fumo contenente numerose sostanze tossiche. Una parte di esso viene infatti esalato dal fumatore mentre un'altra è prodotta dalla combustione della sigaretta tra le dita del fumatore o nel portacenere. Il fumo passivo porta pertanto in sé sia i rischi causati dall'inalazione delle polveri fini che quelli dovuti alla parte gassosa.
«Sono ormai numerosi gli studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni in Europa e negli Stati Uniti che hanno dimostrato come l'innalzamento di 10 microgrammi/m di PM10 sia legato non solo a un aumento di morbilità cardiorespiratoria dello 0,60 per cento, ma anche all'incremento della mortalità per queste patologie», afferma Invernizzi. Queste stime possono essere riportate agli ambienti confinati dove il fumo di una sola sigaretta produce anche 2000-3000 mcg/m di PM 10 che tendono a concentrarsi e a permanere per lunghi periodi. Se si considera che il livello di attenzione per questo 3 particolato è di 40 mcg/m /24 ore per l'ambiente esterno, si comprende quanto malsana e predisponente all'asma e ai disturbi respiratori sia la qualità dell'aria inquinata dal fumo passivo. «A rafforzare questo concetto sono anche i dati elaborati dal Centro europeo ambiente e salute dell'OMS su richiesta del nostro Ministero per l'ambiente in 8 principali città italiane negli anni 1998-1999 su una popolazione totale di 8,3 milioni di abitanti», ribadisce Invernizzi. «Essi hanno stimato che concentrazioni medie di PM 10 superiori a una media di 20 microg/m /anno sono responsabili del 7 per cento dei decessi e dell'8 per cento dei ricoveri. A queste percentuali vanno aggiunti il 35 per cento dei casi di bronchite acuta e il 12 per cento di quelli imputabili alla riacutizzazione di asma al di sotto dei 15 anni di età».
Fonte: mensile Doctor
|
|
![[AmadeuX BiblioForum] [AmadeuX BiblioForum]](https://www.amadeux.it/forum/immagini/amadeuxcomm1.jpg)