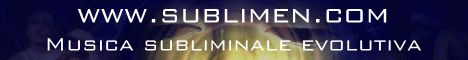|
admin
Webmaster
    
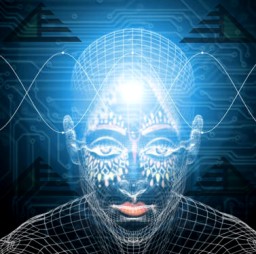
Regione: Italy
Prov.: Pisa
Città: Capannoli

24927 Messaggi |
 Inserito il - 29/03/2011 : 09:45:14 Inserito il - 29/03/2011 : 09:45:14


|
Perché il nucleare ci fa tanta paura? Quello strano dibattito intorno all'atomo
di Marzio Galeotti
Perché abbiamo paura di volare quando statisticamente gli incidenti aerei sono di gran lunga meno di quelli stradali? Perché il nucleare ci fa paura quando le perdite umane associate all'intero ciclo del carbone sono assai superiori? Vi è differenza tra probabilità oggettiva d'incidente e probabilità soggettiva. E ciò ha importanti riflessi sulla decisione di rientrare nel nucleare. Curiosamente, però, dopo Fukushima il dibattito riguarda più i motivi per non uscire dal nucleare laddove già c'è e molto meno i motivi per entrarvi dove, come in Italia, non c'è.
Probabilità oggettiva e soggettiva - Vi è una significativa differenza tra probabilità oggettiva d’incidente e probabilità soggettiva. La prima è basata su un’interpretazione frequentista, calcolata sul numero di occorrenze di incidenti nucleari rispetto al numero o alla durata di attività dei reattori esistenti. Sarà anche un numero piccolo, ma è un fatto che è calcolato ex-post, sulla base dell’osservazione storica dei fatti. Tutt’altra cosa la probabilità soggettiva, perché si basa sulle percezioni e sulle suggestioni, sulle emozioni e sulle sensazioni: logico quindi che in presenza di disastri come quelli giapponesi, tale probabilità possa essere costituita da un numero anche molto elevato e comunque più alto dell’altra. Ma se la probabilità soggettiva di accadimento di incidenti non può essere presa come criterio per decisioni future, ciò non significa che il passato sia un buon previsore, o il migliore, del futuro. Nel caso del nucleare, poi, se si vuole guardare al passato, bisogna riconoscere che nei più gravi incidenti della storia – Chernobyl (Ucraina, scala Ines livello 7) nel 1986, Kyshtym (Ussr, Ines 6) nel 1957, Fukushima (Giappone, scala Ines 5) nel 2011, Three Mile Island (Usa, Ines 5) nel 1979, Sellafield (Regno Unito, Ines 5) nel 1957, Tokaimura (Giappone, Ines 4) nel 1999 – c’è sempre, in un modo o nell’altro, il fattore umano. E allora, quanto è ineliminabile il rischio da fattore umano?Se sulla sicurezza del nucleare in sé è difficile ottenere “ragionevoli” certezze, neppure per le conseguenze sulla salute degli incidenti nucleari ciò pare possibile.
Un dibattito sempre in atto - Da tempo è in atto, e di recente è tornato in auge, il dibattito, a tratti stucchevole, sul numero dei decessi dopo Chernobyl. La verità è che nessuno lo sa con precisione perché è difficile collegare all’incidente le conseguenze a lungo termine dell’esposizione alle radiazioni per sé o per i propri discendenti. Certe sono le evacuazioni e l’inagibilità di interi territori, certe sono le conseguenze fisiologiche e psicologiche della paura di chi è stato esposto, anche limitatamente, alle radiazioni. Vi è infine incertezza sulla completezza e veridicità delle comunicazioni ufficiali, sia dei governanti che dei responsabili delle utilities interessate, che spesso nel passato hanno dimostrato di non dire tutta la verità. Secondo Greenpeace nell’efficiente e precisa Svizzera, dove operano cinque reattori (i tre più vecchi risalgono al 1969, 1971 e 1972), tra il 2000 e il 2009 si sono verificati 130 incidenti di vario genere che sono stati sottoposti a notifica dell’Ispettorato federale sulla sicurezza nucleare e da questo in parte resi noti con pubblica notizia sul proprio sito. Di fronte a queste considerazioni bene hanno fatto paesi come Germania e Svizzera, Austria e Francia, la stessa Commissione europea a fermare le bocce e a decretare l’esecuzione di stress test su tutte le centrali più vecchie. È correttamente da lì che bisogna cominciare a intervenire. E l’Unione Europea, con le sue politiche e la sua Commissione, si conferma una volta di più la bussola da utilizzare per navigare nelle difficili acque dell’energia. Questo pare averlo capito anche il governo italiano nelle sue più recenti dichiarazioni, dopo quelle iniziali, avventate se non improvvide.
Perché entrare nel nucleare? - Anche in vista del referendum la discussione nel nostro paese è ai massimi livelli d’intensità, con giornali e tv che abbondantemente riportano pareri di esperti e di autorevoli commentatori, vuoi a favore vuoi contro l’atomo e la sua reintroduzione sul nostro territorio. È stato osservato che è quasi un paradosso che il dibattito sia più acceso in un paese che l’atomo non ce l’ha. Ma, pur meno apparente, è un paradosso anche continuare a portare argomenti che valgono per i paesi che l’atomo ce l’hanno già. La questione non è tanto “uscire dal nucleare”, come lucidamente discusso per esempio da Pippo Ranci su questo steso sito, ma “perché entrarvi”. Così, in via del tutto generale, un conto è costruire un nuovo reattore in un paese, Francia ad esempio, che di simili impianti ne ha già molti, un conto è farlo dove non ve ne sono. Non è la stessa cosa. Non lo è sul piano dei costi: in uno studio del 2009 Moody’s stimava il costo del kilowattora di nuovi impianti del 35 per cento più alto di quello degli impianti esistenti. (1) Non è la stessa cosa sul piano dei tempi. Costruire un reattore richiede circa cinque anni più i tempi burocratici e amministrativi: l’iter del nuovo reattore Epr finlandese (come quelli che si vogliono fare da noi) è iniziato nel 1998 e si dovrebbe concludere nel 2011-12, mentre il nostro governo stima (stimava, cioè) che il primo reattore sarà connesso alla rete entro il 2020. Dopodiché resterà in attività per sessanta anni. Tutto questo implica un portentoso lock-in, un rimanere vincolati per tre quarti di secolo all’utilizzo di una certa tecnologia impiantata decenni prima e sviluppata ancora più indietro. E dato l’elevato costo la si sfrutterà fino all’ultimo minuto consentito, come è logico. Possiamo ragionevolmente presumere che di qui a settantacinque anni succederanno moltissime cose sul fronte dell’innovazione tecnologica, della lotta ai cambiamenti climatici (sotto il profilo dei risultati e delle politiche), delle fonti fossili di energia e di quelle rinnovabili. E infine, fatto spesso trascurato, sul fronte della dinamica dei consumi elettrici.
Si continua infatti a discutere di questo argomento con l’implicita presunzione che, quanto a elettricità prodotta, il nucleare italiano sia aggiuntivo alle tecnologie energetiche oggi in attività. Ma non è affatto detto che sia così. Il ragionamento, tutto dal lato dell’offerta, non sembra infatti tenere conto della dinamica della domanda che potrebbe risultare debole per un prolungato periodo di stagnazione dell’economia ovvero come conseguenza di efficaci politiche di efficienza e risparmio energetico, peraltro prescritte dagli obblighi contenuti nelle direttive comunitarie. Proprio su questi aspetti poggia la possibile risposta a chi nota che senza nucleare saremmo costretti a continuare a utilizzare chissà per quanto tempo ancora le fonti fossili d’energia, importate dall’estero. È probabilmente vero, e lo dice la stessa Agenzia internazionale dell’energia quando osserva che anche nello scenario virtuoso di stabilizzazione delle concentrazioni di gas-serra a 450 ppm i combustibili fossili soddisfaranno più del 60 per cento dei consumi di energia primaria mondiale al 2035, con il nucleare al 17 per cento. (2) Ma nel frattempo importanti opzioni andranno perseguite e adottate con decisione. Una di queste è l’efficienza energetica, da conseguire nel nostro paese con una determinazione e con mezzi che ancora non si sono visti. (3) Per l’Enea la riduzione delle emissioni italiane al 2020 secondo la misura stabilita dalle direttive europee fa perno sul ricorso a misure di efficientamento negli usi finali di energia per il 46 per cento (il 15 per cento nel settore residenziale) e nella generazione elettrica per il 12 per cento. Sempre l’Enea nel 2009 presentava uno studio per un Piano nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico, che dimostra quanto rilevanti siano i risparmi di un intervento a tappeto su scuole, uffici, ospedali, eccetera. (4)
Problemi tutti italiani - E da ultimo va detto che un conto è costruire, gestire e controllare impianti nucleari in un paese efficiente, solidale e onesto, un conto è farlo in un paese che non sempre ha brillato su tali fronti. Dopo Fukushima, anche da questo punto di vista le cose non possono più essere come prima. E allora è necessario non dimenticare che il paese della rinascita nucleare prossima ventura è quello dove si pianificano centrali lungo un fiume il cui livello scendeva a -7,53 metri nel luglio del 2003 per la siccità, creando problemi per l'alimentazione della centrale elettrica di Porto Tolle, che è la più grande del Nord Italia, situazione che si ripresentava nell’estate del 2006. Ed è anche quello dove, complice una pianificazione territoriale assente e un utilizzo del suolo quanto meno scellerato, nel 1998 un’alluvione determinava un gravissimo fenomeno franoso, che interessò la metà del territorio comunale di Sarno in Campania causando la distruzione di molte abitazioni e la morte di 137 persone. Ed è ancora quello dove nel 2009 la procura di Agrigento ordinava lo sgombero dell’ospedale San Giovanni di Dio “per gravi carenze nella qualità del calcestruzzo utilizzato”, e questa è solo una delle numerose opere pubbliche finite nella black list. È infine il paese dove quest’anno abbiamo scoperto che il percolato delle decine di discariche attivate per far fronte alle emergenze dello smaltimento dei rifiuti urbani del napoletano veniva conferito a depuratori non funzionanti o privi delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei reflui fognari. In pratica, finiva in mare senza nessun trattamento che ne assicurasse la depurazione o almeno l’abbattimento del potenziale di inquinamento. È alla luce di tutto questo che un referendum su questioni di principio e strategiche per la nazione, e che dunque in condizioni normali forse non andrebbe svolto, viene ad assumere un senso e una rilevanza rispetto ai quali gli italiani dovranno mostrare sufficiente maturità da non far mancare il quorum.
(1) Moody's, “New Nuclear Generation, Ratings Pressure Increasing”, July 2009.
(2) IEA World Energy Outlook 2010.
(3) Nonostante il Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica del 2007, come previsto dalla direttiva europea 2006/32/Ce, mentre vivo è ancora il ricordo delle vicende della famosa detrazione del 55 per cento sulla riqualificazione energetica degli edifici. Da segnalare è il contributo di Confindustria con le sue “Proposte di Confindustria per il Piano straordinario di efficienza energetica 2010”.
(4) Si veda: http://www.enea.it/eventi/eventi2009/InvestimentiEffEne260209/Intervento_ENEA.pdf
Nella fase di cantiere l’investimento nel Piano di 8,2 miliardi di euro determina i seguenti effetti: produzione attivata per circa 20 miliardi di euro, creazione di valore aggiunto pari circa 15 miliardi di euro, incremento dell’occupazione di circa 150mila unità, incremento complessivo del Pil dell’ordine dello 0,6 per cento (nell’arco temporale dell’intervento). Nella fase a regime il risparmio energetico, pari a circa 420 milioni di euro/anno, si stima provochi i seguenti effetti: produzione attivata pari a 23 miliardi di euro, creazione di valore aggiunto pari a 17 miliardi di euro. Non sono inclusi nelle stime in quanto di difficile quantificazione ulteriori benefici come il miglioramento della produttività del lavoro, il miglioramento della qualità ambientale del posto di lavoro, la maggiore sicurezza degli edifici.
23 marzo 2011
Marzio Galeotti (Lavoce.info)
|
|
![[AmadeuX BiblioForum] [AmadeuX BiblioForum]](https://www.amadeux.it/forum/immagini/amadeuxcomm1.jpg)