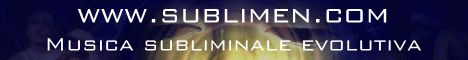|
admin
Webmaster
    
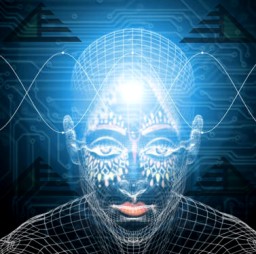
Regione: Italy
Prov.: Pisa
Città: Capannoli

24820 Messaggi |
 Inserito il - 19/03/2010 : 10:05:19 Inserito il - 19/03/2010 : 10:05:19


|
La pace è da cercare dentro
Lunga intervista di L. Minerva con Tiziano Terzani
Tiziano Terzani
"La pace è da cercare dentro"
(FIRENZE - 04/08/2004)
Quando arrivammo nella sua casa di Bellosguardo, a Firenze, alle 11
del mattino, ne usciva una troupe della televisione svizzera. Era lì
da due giorni, l’operatore era lo stesso con cui Tiziano Terzani aveva
girato immagini in Vietnam. Insieme alla moglie Angela venne ad
aprirci lui, tutto vestito di bianco con un sorriso solare e, dopo le
presentazioni, il benvenuto e le strette di mano, ci chiese subito,
marcando l’accento fiorentino: «Non ci avrete mica il foco al culo» e,
precisando per paura che non avessimo capito: «Non andate di fretta,
vero?» «No, abbiamo tutto il giorno.» «Finalmente qualcuno che non va
di fretta.»
Per nessun altro libro Tiziano Terzani si era reso disponibile per
presentazioni pubbliche e interviste. I libri uscivano e lui restava
lontano, gustandosi sotto i baffi il successo di critica e di pubblico
e la scalata nella classifica delle vendite, quasi automatica. Ma le
Lettere contro la guerra erano per lui più di un libro. Non erano più
il resoconto di un inviato, la sintesi del suo sguardo attento e acuto
su realtà quasi sconosciute agli altri. Erano il frutto di una
riflessione sul rapporto tra l’uomo e il mondo, quella riflessione in
cui lui era impegnato, per suo conto, ben prima dell’11 settembre. Il
suo 11 settembre personale, la caduta delle torri delle sue certezze
(«signor Terzani, lei ha un cancro»), proprio a New York, era avvenuta
quattro anni prima delle Twin Towers. E da lì, ma l’abbiamo imparato
tutti solo pochi mesi fa, lui aveva cominciato un altro viaggio più
misterioso e profondo, quello dentro se stesso.
La sua «buona occasione per ripensare tutto» l’aveva già portato su
altre strade, su quell’Himalaya che amava e in cui poteva continuare a
esplorare l’ignoto, senza dover realizzare alcun reportage. Lì
finalmente poteva conoscere per puro piacere, senza avere nessuna
urgenza e nessun bisogno di narrare. Ma l’eco dell’11 settembre era
arrivato fin lì. «Quelle immagini terribili le abbiamo viste tutti,
perché tutti abbiamo degli amici, anche a me mi ha chiamato un amico,
meno male c’è l’amicizia» avrebbe raccontato all’incontro pubblico al
Festivaletteratura di Mantova. E quel guardare dentro se stesso non lo
aveva isolato, ma lo aveva rimesso in connessione con il mondo, con il
resto del mondo, con tutti i lettori potenziali, con quella voglia di
pace che cercava più argomenti e forza possibile. Solo per questo e
solo in quell’occasione, ai primi di marzo del 2002, pochi giorni dopo
l’uscita delle Lettere, poteva accadere che due troupe televisive si
incrociassero sulla porta di casa sua.
Non si poteva parlare delle Lettere contro la guerra in poche battute,
bisognava entrare prima in sintonia tra interlocutori, superare lo
stupore per l’interno di casa indiana trasportato su una collina
fiorentina, sedersi gustando un tè, conoscere lui e Angela, guardarsi
negli occhi, raccontarsi qualcosa che nulla aveva a che fare con
l’intervista. In quella casa siamo rimasti, con l’operatore Licio
Fatucchi e il suo assistente Sebastiano Foschi, per sette ore: per
scegliere con cura le inquadrature che raccontassero il luogo, per
curare le luci che rimandassero al meglio il suo sguardo, i suoi
movimenti, la sua mimica, quella luce particolare che si rifletteva
nel bianco dei suoi vestiti, per vederlo provare e riprovare (e ci
prendeva gusto) la lettura di alcuni brani scelti insieme da quelle
lettere.
E per restare, alla fine del lavoro, a parlare ancora di pace, di
guerra, di conflitti globali e personali, del profumo di incenso che
ci accompagnava e che a suo avviso era il migliore di quelli indiani.
E’ stata la prima volta che, prima dell’intervista, qualcuno mi ha
chiesto: «Possiamo fare un minuto di meditazione o di silenzio, perché
il vostro lavoro riesca al meglio e ciò che diremo sia detto nel
migliore dei modi possibili?» Lì mi sembrò la cosa più naturale del
mondo. Oggi, come se quel minuto durasse ancora, mi sembra utile che
l’intera intervista, e non solo la sua sintesi contenuta nei dodici
minuti televisivi, possa arrivare al pubblico più ampio. Alla luce dei
segreti della vita che lui conservava per sé e che ha poi svelato
nell’ultimo libro, le sue parole di quel colloquio acquistano un
significato ancora più intenso.
L’intervista di Luciano Minerva
Nel 1994, scrivendo "Un indovino mi disse", intitolò il primo capitolo
"Benedetta maledizione" e cominciò con "Una buona occasione nella vita
si presenta sempre. Il problema è saperla riconoscere e a volte non è
facile." Nella prima parte delle sue nuove "Lettere contro la guerra"
parte ancora da questo concetto della buona occasione, questa volta su
scala mondiale.
Trent’anni d’Asia mi hanno convinto profondamente di una cosa: che il
bello della vita è l’armonia degli opposti. E forse il fondo di tutto
quel libro è proprio questo: l’idea che la vita è fatta dei contrari,
che l’uomo ha la sua ombra, che non puoi eliminare la sua ombra.
Allora, il simbolo che mi pare più bello per spiegare questo concetto
è quello del Tao: lo yin e lo yang, la luce e la tenebra, e non c’è
soltanto questa contrapposizione, ma il bello è che all’interno della
tenebra c’è un punto di luce e all’interno della luce c’è il seme di
tenebra. E dinanzi a questo orrore delle torri, dinanzi a questo
spaventoso senso della grande insicurezza che la mia vita e quella di
tutto il mondo stava per avere, ho visto il positivo. E nella testa,
immediatamente, dinanzi a questa orrenda tenebra, mi è venuta un’idea:
"ah, una buona occasione". Una buona occasione, una buona occasione
per ripensare tutto, perché il mondo mi pareva assolutamente cambiato
per sempre. Si trattava ora di accettare questo e di cominciare a
cambiare noi, per cui una buona grande occasione, per l’umanità, per
l’Uomo con la lettera maiuscola, di prendere un’altra strada.
Invece, aggiunge subito dopo, l’occasione è stata quella di aizzare il
cane che è in ognuno di noi. E a questo ha pensato poi di reagire, per
cui nella luce che aveva trovato nel silenzio, nell’abbandono del
lavoro di inviato, ha deciso che doveva ritornare l’ombra, o la luce,
dello scrivere
Per trent’anni ho fatto il corrispondente di guerra, per trent’anni ho
vissuto in Asia, seguendo sempre tutte le storie, i massacri, i
diluvi, le guerre, e a sessant’anni avevo preso, asiaticamente, la
"pensione". In verità io non ho mai lavorato in tutta la vita, sono
stato fortunatissimo, perché ho sempre fatto le cose che mi piacevano
e mi hanno anche pagato, per cui non è che aspettavo la pensione come
la liberazione da quest’orrore del lavoro alienante. Ma ho sempre
viaggiato fuori, e a sessant’anni mi pareva giusto chiudere con il
mondo e fare un altro viaggio. E allora mi sono preso "la pensione" e
sono andato a vivere in cima all’Himalaya, in una capanna senza luce,
senz’acqua, senza telefono. Ho cominciato un altro tipo di vita,
chiudendo col mondo, chiudendo i contatti della conversazione. In
inglese si dice così bene: dipende da con chi sei solo, e questo mi
piaceva.
E l’11 settembre mi ha sconvolto, ho capito che non potevo più
permettermi questo lusso di guardarmi l’ombelico, mi sono rimesso a
fare quello che so fare, viaggiare, ma questa volta da libero,
completamente libero. Non più l’articolo da scrivere per le nove di
sera, che comincia con la frase che attira il lettore, nel terzo
paragrafo bisogna spiegare qual è il problema, nel quinto una battuta
e poi si finisce con una storiella significativa e ho scritto
d’istinto le lettere, senza una regola, senza una costrizione. Le
lettere sono nate così: la prima immediatamente dopo i fatti dell’11
settembre indirizzata al Corriere della sera perché dovevo far
partecipi i lettori della mia esperienza con i terroristi. La seconda,
in reazione alla lettera della mia concittadina (Oriana Fallaci,
N.d.R.) che mi aveva proprio sconvolto nel suo grido di rabbia secondo
me mal riposta, meschina in fondo; e poi mi aveva preoccupato
l'impatto che avrebbe avuto sui giovani quando ciò che lei aveva
scritto veniva letto nelle scuole. Mi aveva molto preoccupato perché
quel cane di cui lei parla è in tutti noi, in ognuno di noi c'è una
bestia pronta a svegliarsi e ad azzannare il vicino. Il problema è
tenerla al guinzaglio, mettergli la museruola, invece qui era proprio
scatenata.
Dopo questa erano venute altre lettere, alcune pubblicate sul Corriere
della sera, altre no, che ho dedicato a mio nipote che è un bambino di
due anni e mezzo e anche lui un giorno dovrà affrontare il problema di
scegliere tra la violenza e la non violenza e io non ci sarò più, non
sarò più in questo corpo e potrà ricorrere a questo vecchio nonno
barbone perché scelga la pace. Per questo anche in questo viaggio che
sto facendo in Italia mi piace parlare con i giovani perché i giovani
sono pronti al nuovo. Qui si tratta di reinventare tutto, si tratta di
reinventarci il futuro e i vecchi, anche quelli come me, hanno
difficoltà. Il cambiamento è la cosa più terribile che si possa fare,
e quando uno nella vita ha accumulato l'esperienza sulla base del suo
sapere e fa saggezza, non può facilmente mutare. E infatti il non
mutare la ragione, le abitudini, gli automatismi ci ha portato allo
sgomento dell'11 settembre. Se vogliamo evitare questo, dobbiamo
cominciare a pensare in maniera nuova, ad avere reazioni nuove a certe
azioni. I giovani vogliono avere speranza, i giovani sono nati per
sperare, ai giovani il nuovo non fa paura e i giovani possano
reinventare il futuro. Gliel’abbiamo tolto di mano.
Ai giovani avevamo promesso un futuro di New Age, la nuova era, l'era
dell'acquario, il benessere, la felicità, la fratellanza. E guarda
cosa gli abbiamo messo davanti: le torri… perché così è l’uomo: Bush,
i musulmani, i non musulmani, alla fine siamo tutti umanità, per cui
le torri, l’orrore criminale delle torri siamo noi e l’orrore
criminale delle bombe siamo noi. Ai giovani non possiamo togliere la
speranza, dobbiamo dire qualcosa di nuovo, dobbiamo dire che forse
questa è la buona occasione, perché l’abbiamo visto tutti quanto è
orribile. Non è come la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki di cui
leggemmo, di cui vedemmo una fotografia, di cui ci è stato raccontato
a scuola. Questo tutto il mondo l’ha visto non una volta ma dieci,
cento volte dinanzi.
Ed era facile immaginarci che a quella orribile violenza noi, dico noi
tutti, gli americani, l’Occidente, avremmo reagito con una uguale e
forse superiore violenza e che gli altri, prima o poi, risponderanno
con una superiore violenza e noi andremo ancora con la violenza . E
alla fine? Rimarrà qualcuno ancora ad usare la violenza? Non è questa
una buona occasione per fermarci riflettere e prendere un’altra via,
quella della non violenza, reinventando i modi della non violenza? Non
guardi la mia barba, il mio sembrare un indiano per cui parlo di
Gandhi. No, io sono un vecchio fiorentino, questo è parte del mio
camuffamento per entrare nel mondo. In Afganistan era meravigliosa la
mia barba: mi guardavano, mi chiedevano ‘Musulman?’ E io ‘…hmm’, così
che lasciavo alla tolleranza, all’esser preso per uno di loro.
Non è la non violenza di Gandhi, non è il digiuno di Gandhi che
ripropongo, cerco di reinterpretare la non violenza in chiave moderna.
Per esempio il consumismo ci consumerà, e l’unico modo per non essere
consumati dal consumismo è il digiuno, ma non quello gandhiano di non
mangiare, quello di non comprare le cose inutili, quello di non cadere
in questa trappola, per cui c’è un modo moderno secondo me, che noi
tutti dobbiamo riscoprire, che dobbiamo incoraggiare i giovani a
riscoprire, di essere non violenti e di trovare un altro modo di
convivere. E ora ritorno al punto che mi riguarda così tanto:
quell’unità, quell’armonia degli opposti. Non possiamo pensare di
eliminare il male, innanzitutto perché chi definisce il Male? Gli
altri dicono che noi siamo il Male, noi diciamo che loro sono il Male:
se cominciamo a cercare di eliminarci l’un l’altro finiremo che ci
eliminiamo tutti perché oggi i mezzi di distruzione sono spaventosi.
Allora l’unico modo non è uno scontro di civiltà, ma un dialogo di
civiltà.
Dobbiamo capire chi sono, dobbiamo capire che cosa fa di un uomo un
terrorista. Non elimineremo mai il terrorismo uccidendo terroristi, ma
soltanto eliminando le ragioni che portano un uomo come noi, che nasce
per vivere, per essere felice, a fare quell’atto più innaturale, più
disumano, che è quello di uccidersi e di uccidere. Allora se si dice
questo ai giovani si rimette il mondo nelle loro mani. I giovani oggi
si sentono separati, marginalizzati, sentono che il mondo è troppo
complicato, e vederlo è complicatissimo. Come ci si può mettere un
dito e cambiar qualcosa? Sa quando si gioca a biliardo? Do un colpo e
tutte le palle vanno nella propria direzione. Basta però che lei metta
un pollice e dia un diverso colpo ad una palla soltanto e tutto il
gioco cambia. Questo è quello che mi piacerebbe stimolare la gente a
fare: solo un piccolo tocco ad una palla, un gesto personale, rivedere
un atteggiamento, un fare distanza prima di essere violento, un
riflettere, un rimettersi a pregare al mattino, ritrovare un attimo di
concentrazione, riprendere coscienza e forse da quella piccola cosa
viene qualcosa di più grande e se ognuno fa una piccola cosa tutti
assieme ne faremo una grandissima e forse riusciremo a prendere
un’altra via.
"Fondata ai tempi dell’invasione sovietica in Afganistan l’Università
è uno dei tanti esempi di come lo sforzo americano per sconfiggere
l'Unione sovietica ha messo al mondo dei mostri che vivono ora una
vita tutta loro e di cui nessuno sa esattamente come riprendere il
controllo. Queste lei scrisse nel libro ‘In Asia’ del 1995 parlando
dell’Università della Jihad di Peshawar. Mentre scriveva le ‘Lettere
contro la guerra’ è tornato a Peshawar con lo stesso atteggiamento
dell’inviato. E dice: "come fossi tornato nella minestra per sapere se
è salata o meno ora ho l’impressione di affogarci dentro".
Affogarci perché questa volta la guerra è stata incredibile: è la
guerra che è stata coperta fin qui dal maggior numero di giornalisti.
Se uno guarda le pagine che sono state scritte, le ore di televisione
che le sono state dedicate, forse è la guerra più coperta che sia mai
esistita, eppure è la guerra di cui abbiamo saputo di meno. E’ una
guerra non solo di bombardieri, di bombe intelligenti che poi facevano
le stupidaggini come bombardare i civili. E’ stata una guerra di
bugie, di grandi bugie, di mezze verità. E’ stata una guerra in cui il
depistaggio delle informazioni è stato straordinario. Peshawar: un
solo albergo, in cui sono concentrati tutti i giornalisti; una voce,
una falsa notizia in fa il giro di tutto il mondo nel giro di pochi
secondi, e tutti dal tetto di quest’albergo trasmettono questa bugia,
questa mezza verità. Poi c’è l’impossibilità per i giornalisti di
controllare, non hanno più il tempo di farlo: ventiquattr’ore su
ventiquattro bisogna produrre qualcosa, così anche una bugia di cui
poi si scopre che tale era, non viene smentita, perché c’è un’altra
cosa da raccontare.
Mi sono sentito come affogare perché era difficilissimo capire che
cosa succedeva. Gli americano sono stati abilissimi in questo, perché
hanno ben imparato la lezione del Vietnam. Quando un giornalista come
me, italiano, che lavoravo per un giornale tedesco, è arrivato in
Vietnam nel 1971, mi è stata data una identity card con la mia foto in
cui c’era scritto: Tiziano Terzani, U.S. major, maggiore dell’esercito
Usa. Non che comandassi le truppe, ma avevo la priorità di un maggiore
per salire sui camion e sugli elicotteri per andare al fronte. E’
ovvio che con questo tipo di apertura, di generosità nei confronti
dell’informazione, gli americani hanno perso la guerra a casa. Perché
quando si andava al fronte a verificare qualsiasi notizia e a vedere
quella cosa che la guerra è, orribile, era impossibile poi, col
fattore moltiplicatore dell’informazione, che non si creasse a casa un
fronte contro la guerra.
E così la lezione è stata imparata benissimo. La guerra del Golfo è
stata già tenuta molto lontana dai giornalisti, questa è stata tenuta
ermeticamente chiusa ai giornalisti. Per la prima volta la verità, per
così dire, è stata continuamente impacchettata. C’era sempre bisogno
di quelli che gli americani chiamano ‘spin doctors’ per raccontarla.
La verità non c’era, c’era solo il pacco e dentro c’era di tutto. Gli
esempi sono straordinari. Pensi alle prime sequenze dei video delle
truppe specialissime americane che non potendo più acchiappare Osama
Bin Laden andavano alla caccia di Mullah Omar. Si vedevano tutti
questi omini verdi, sembrava un videogame per dare l’impressione che
la guerra non è questo orrore che è, è come se il morto poi si rialza
e riparte. C’è stata una grande operazione americana, di grande
abilità per turlupinare il mondo, per rappresentare il nemico come la
cosa più orribile, più atroce, e per coprire qualsiasi magagna di
questa nostra parte. Creava sgomento l’impossibilità di verificare i
fatti. Uno come me, per mestiere per tutta la vita, ha cercato sempre
di capire le ragioni degli altri. Nel ’73 sono uno dei giornalisti che
passa le linee del fronte e va dai vietcong per capire "chi sono
questi che mi tirano sempre addosso", che mi costringono a sperare che
i ‘nostri’ mi difendano. Allora anche questa volta sono voluto andare
di là.
Ed è stato difficile, ma sono riuscito a parlare con i jihadi, con i
giovani che partivano per andare a combattere gli americani e ho poi
rivisto i pochissimi sopravvissuti quando tornavano: di un gruppo di
43, in un villaggio fuori da Peshawar, ne erano tornati tre soltanto,
tutti gli altri … fatti a pezzi dai B52. E’ interessante sentirli
parlare, perché quello che sentivo dentro di me, che le bombe non
uccidevano terroristi, ma creavano nuovi terroristi l’ho avuto davanti
agli occhi. A uno di questi terroristi ho chiesto: ‘e ora lei cosa
fa?’ ‘Aspetto ordini.’ ‘Ordini di che? E se le ordinano di mettere una
bomba a New York?’ ‘Ah, ci vado subito’. E si deve capire questo
perché bisogna sempre capire anche la logica del nemico, degli altri.
Lui ha visto massacrare 40 persone, i suoi compagni, accanto a lui,
uccisi dalle bombe scaricate da un uomo che stava a quindici
chilometri di altezza. Come può pensare lui, nel suo modo di concepire
la vendetta, di rifarsela con quell’uomo? Che forma può avere per lui
la vendetta? Solo il terrorismo, perché l’asimmetria delle armi, del
potere di quello lassù contro questi che non avevano niente per
raggiungerlo, spiegano il terrorismo. Quindi l’unico modo per
eliminare il terrorismo è eliminare le ragioni che spingono ragazzi
come quello ora ad andare a New York e sognare di mettere una bomba in
un supermercato.
Dopo aver fatto una scelta di ritiro solitario alle pendici
dell’Himalaya ha deciso, dopo l’11 settembre, che era il caso di
scendere in pianura, e scendendo in pianura è sceso in questa pianura
italiana. Come ha ritrovato quest’Italia dopo tantidecenni vissuti
all’estero?
Mi sento profondamente fuori luogo, mi sento straniero ovviamente, in
fondo manco da trent’anni, anche se ritorno ogni anno perché ho
famiglia e ho amici. Ma provo tante sensazioni: un grande
impoverimento, non materiale, ma da tanti punti di vista. Per esempio:
prendo il treno. Ero abituato ai vecchi treni, si sta nello
scompartimento, si chiacchiera, lei dove va, da dove viene, una
lezione di vita. Ora vai in un treno, ognuno va per conto suo e sembra
d’essere in una grillaia, trr, trr, trr, quello parla con l’amante, un
altro corregge le bozze di un libro. C’è da impazzire. Mi meraviglia
tanto come questo italiano, noi, si sia separato dal mondo in cui
vive, è un continuo essere al lavoro. I giovani. Li vedo un po’
insciattiti, si vestono male. Ai miei tempi studiavano già da grandi.
E un'altra cosa: sono andato in una scuola per parlare della pace,
della non violenza e un ragazzino di quindici-sedici anni mi ha dato
del tu. Mi ha sorpreso, non perché mi sentissi offeso, ma io sono
cresciuto in un Italia in cui si dava ancora del voi ai nonni, del tu
ai genitori, ma a chiunque fosse un po’ più vecchio di te, si dava
immediatamente del lei, non perché uno è giù e l’altro è su, ma perché
la lingua ha questa ricchezza. Mi sembra anche questa una forma di
impoverimento. Poi c'è un involgarimento delle città. Penso a Firenze,
questa straordinaria, bella città in cui sono cresciuto.
Una delle vie principali che prima era il salotto di Firenze, via
Tornabuoni. Nel giro di uno-due anni sono scomparsi un vecchio negozio
di musica, un vecchio bar, una vecchia farmacia, tutto sostituito da
negozi di moda: è un impoverimento, secondo me, anche se il libro è
stato sostituito da un vestitaccio che costa cinque milioni. Penso
alla strada che facevo per andare a scuola, e questo è un cambiamento
che è avvenuto dovunque: era una serie di botteghe nelle quali c’era
sempre un uomo che cantava qualcosa facendo qualcosa, una seggiola,
riimpagliando una poltrona, lucidando un mobile. Questa era la Firenze
operaia nella quale sono cresciuto. Oggi ognuno di questi negozi è una
boutique dove c’è un venditore, un bottegaio che non fa niente, vende
qualcosa prodotto magari in Corea, e lo vende ai giapponesi. Per cui
c’è un progressivo impoverimento nella ricchezza materiale e questo mi
fa molto riflettere sul futuro. Perché se il cambiamento che ho visto
nel corso della mia vita continua con quella accelerazione che ormai
conosciamo, dove finisce quest’uomo e dove finisce questa bella
diversità? Mi chiedo oggi cosa vuol dire essere fiorentino.
"Quand’ero ragazzo il mondo mi pareva pieno di grandi, grandi
politici, grandi artisti, grandi maestri. Ora un giovane che si guardi
attorno riesce ad identificarne pochissimi e anche quelli sembrano
destinati a durar poco". Assenza di maestri da un lato e assenza di
dubbio dall’altro. Nelle sue Lettere scrive tra l’altro: dubitare è
funzione essenziale del pensiero: il dubbio è il fondo della cultura.
Voler togliere il dubbio dalle nostre teste è come voler togliere aria
ai nostri polmoni. Che aria c’è in questo momento senza maestri e con
pochi dubbi?
Una brutta aria. Secondo me non mancano soltanto i grandi maestri, mi
sto rendendo conto che mancano i piccoli maestri, il mio maestro delle
scuole elementari, quello che mi ha insegnato a non mettermi le dita
nel naso, quello che mi ha insegnato le belle cose della vita
quotidiana, quello che mi ha insegnato ad essere onesto e non furbo,
quello che insegna a rispettare il prossimo, il vicino. Mancano i
grandi maestri, ma questo è anche un effetto del nostro tempo. C’è
un'altra parte del mio libro, in cui cito il VI secolo avanti Cristo
in cui c’è un accumularsi di grandi personaggi: nascono Socrate,
Platone, Buddha, Zoroastro, personaggi incredibili, tutti concentrati
in un piccolo spazio di tempo, come se le stelle in qualche modo
avessero creato una strana coincidenza. E devo dire anche nella mia
infanzia c’erano tanti grandi, di diverso tipo, anche grandi
assassini, Mao, Stalin, ma grandi. Ora è tutta una mediocrità e lì c’è
un discorso che non va troppo fatto in pubblico o non troppo
precisamente: mi chiedo se in fondo anche la democrazia come noi la
pratichiamo non è una perversione della democrazia originale perché in
fondo non fa che portare al potere, far levitare, la mediocrità, i
piccoli, quelli che dicono le cose banali.
Lei scrive ad esempio che in India ci sono sempre più gangster e
corrotti eletti in libere elezioni e che in Giappone la mafia, la
Yakuza sono ufficialmente riconosciuti, censiti e rappresentati in
parlamento. E’ questa la democrazia che va a sparire?
Sì, per tanti versi sì, ma pensi all’Unione sovietica. Lei forse ha
visto il mio libro "Buonanotte, signor Lenin": ho avuto davanti agli
occhi, visto, palpato, annusato che il vuoto che lasciava il marxismo
leninismo, il controllo di un potere autocratico per tanti versi,
veniva riempito da tante cose: la mafia, i banditi, il Kgb che si
ricicla i mafiosi e dall’altra parte il marxismo-leninismo che trova
un suo surrogato in un’altra nuova ideologia, ed è lì che per la prima
volta me la sono trovata davanti, in Asia centrale: il fondamentalismo
islamico. E allora la mancanza di grandi, la mancanza di una guida, la
mancanza di una cosa più semplice, più naturale, più giusta, è quello
che crea grande disorientamento fra i giovani, che secondo me non
vedono dove stiamo andando, non hanno un ideale, gliel’abbiamo tolto.
Abbiamo tolto il senso che la vita ha qualche senso e che il senso è
andare in su invece che andare in giù. In fondo è questo che mi ha
spinto a scrivere queste lettere, l’idea che l’umanità è a una svolta.
E’ una svolta verso una progressiva barbarie: le gabbie di Guantanamo,
la rinuncia agli accordi di Ginevra, che sono costati cento anni di
limatura, oppure una scelta verso una maggiore spiritualità, una
minore insistenza sulla materia, con l’uomo che prende la strada per
l’insù invece che per l’ingiù. Questo è quello che per me è
significato l’11 settembre.
Lei parla spesso di morale, di etica e, richiamando anche i grandi
scienziati cita una frase di Einstein...
Bellissima: Ricordiamoci della nostra umanità. Sono le ultime parole
del manifesto che scrisse poco prima di morire, ed è vero, ed è
importantissimo: bisogna riintrodurre l’etica, la moralità nella
nostra vita, nella politica. E’ il momento di smettere con
l’ipocrisia, le cose dette per avere voti, le cose dette per piacere a
qualcuno in quel momento e poi voltarsi e dire il contrario di quello
per far piacere agli altri. E’ lì dove c’è la grande confusione oggi.
Ed è lì che i musulmani hanno una grande forza oggi, che è la forza
della fede, una certa ottusità se vogliamo, ma dei principi, un’idea.
Pensiamo a Madre Teresa o a un’altra persona che mi piace moltissimo
di quelle che si incontrano nella vita di un giornalista, il Dalai
Lama. Qual è la loro forza, dov’è la loro grandezza? nella semplicità.
Hanno una o due idee, ma quelle forti, a quelle si attaccano e quelle
determinano la loro vita. Noi abbiamo perso questa intensità, siamo
pieni di tanti stimoli, di tante cose, abbiamo tante distrazioni e non
riusciamo a tenere una linea, ad avere un’idea che determina tutta la
nostra vita. Per questo secondo me è il momento di reintrodurre la
morale, di riintrodurre il giusto nella vita quotidiana, di
reintrodurre la morale nella politica.
Durante un’intervista in India al giovane Agnelli, Giovanni Alberto
Agnelli, le veniva in mente una frase di Thomas Stearns Eliot: «Dov’è
la vita che abbiamo perso vivendo, dov’è la saggezza che abbiamo perso
con la conoscenza, dov’è la conoscenza che abbiamo perso con
l’informazione?» E aggiunge: «Ho l’impressione che più informazione
abbiamo e più siamo ignoranti.»
Questo è vero per tutto, non solo per la conoscenza, è vero per le
comunicazioni: oggi è un continuo parlarsi, telefonini, e-mail, e in
verità comunichiamo sempre di meno. Ci è successo qualcosa di
perverso: ci stiamo come ingolfando di comunicazioni, di contatti, di
cose che sappiamo e in verità in questo grasso di tante cose moriamo.
Ed è lì che io torno a dire: l’unico modo per reagire è digiunare,
prendere le distanze, ridurre. Internet è un simbolo di tutto questo:
un grande vantaggio, un mare stupendo, ma pericolosissimo, un mare in
cui si può andare a picco. Innanzitutto perché non c’è alcuna
discriminazione: tutte le informazioni hanno lo stesso valore, lo
stesso livello. Qualsiasi pazzo che mette qualcosa di assolutamente
assurdo è allo stesso livello di qualità apparente di qualcuno che ha
speso la vita per arrivare a una conclusione. Per cui ritorno al
solito punto che mi pare la mia ossessione ormai: che bisogna dominare
la modernità e non esserne dominati. E questo vale per ogni aspetto:
la saggezza, la comunicazione. Il fondo di tutto è che bisogna
semplificare ciò che è complicato e arrivare a quelle tre-quattro
piccole cose che sono grandi perché che sono importanti.
Le quarte di copertina dei suoi libri portano di volta in volta le sue
fotografie delle varie epoche. Gradualmente si vede cambiare fino a
questa aria quasi da santone indiano. Cos’è cambiato e cos’è
permanente in questo Terzani degli anni 70 e 80, cos’è cambiato e
cos’è permanente in questi volti?
Sa cosa si dice in India? Che il fiume in cui si mette in primo piede
per fare il bagno non è più lo stesso fiume in cui si mette il
secondo, per cui io non sono più quello là, sono cambiato moltissimo.
Se c’è un filo conduttore è la mia curiosità di quel che c’è attorno,
di quel che succede. Ma io sono cambiato, sono cambiato tantissimo, né
tengo, devo dire, a rimanere lo stesso, mi piace questo cambiare:
l’impermanenza è una condizione naturalissima dell’essere in tutte le
sue forme e non vedo perché uno dovrebbe resistere. Non mi piacciono
quelli che rifiutano il divenire. Per esempio io adoro essere un
vecchio, mi piace essere vecchio, non vedo perché dovrei tingermi i
baffi, i capelli, far finta di essere ancora quello di prima. E’
bello. E’ bella questa impermanenza, questo mutare, perché è una
continua riscoperta. Per questo non credo che mi farò il face-lifting
o mi tingerò i capelli.
|
|
![[AmadeuX BiblioForum] [AmadeuX BiblioForum]](https://www.amadeux.it/forum/immagini/amadeuxcomm1.jpg)