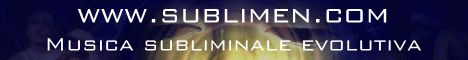|
admin
Webmaster
    
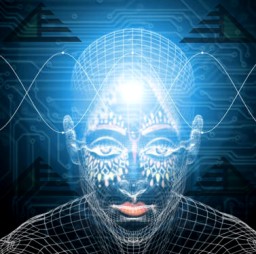
Regione: Italy
Prov.: Pisa
Città: Capannoli

24820 Messaggi |
 Inserito il - 29/01/2010 : 10:58:14 Inserito il - 29/01/2010 : 10:58:14


|
Le relazioni e il Dharma
di Corrado Pensa
Questo scritto è solo in parte connesso all’articolo La relazione
coniugale come via di crescita nel Dharma, in Paramita, 52 (1994), pp.
5-11.
La maggior parte dei praticanti di Dharma occidentali non sono monaci
o monache che abitano in comunità, ma sono per lo più laici che vivono
in casa propria, svolgono un’attività, hanno famiglia oppure, se non
hanno una famiglia, sono spesso in una relazione di coppia.
Ora una relazione fondata sopra un saldo impegno reciproco può
diventare un terreno molto fertile per praticare l’insegnamento del
Buddha. E ciò con beneficio sia della relazione, sia della pratica
individuale. Tenendo presente che è possibile avere due tipi di
‘relazione dharmica’: nella prima entrambe le persone sono dedite alla
pratica, nella seconda solo una persona è praticante, mentre l’altra
non lo è, ma guarda tuttavia con simpatia e solidarietà al cammino del
coniuge 1. Arnaud Desjardins non esita a dichiarare che "l’unica
relazione che può essere o può comunque gradualmente diventare così
ricca e perfetta come la relazione con il guru è la relazione tra
moglie e marito" 2. Ritorneremo su questo punto.
Osserviamo ancora questo: per chi è in una relazione dharmica il
sangha è costituito da due cerchi, uno esterno e l’altro interno. Il
cerchio esterno è rappresentato da amici di Dharma, ossia persone con
le quali noi pratichiamo periodicamente, gli insegnanti, e chiunque
incoraggi e sostenga il nostro impegno nel Dharma. Il circolo interno,
invece, è rappresentato dal nostro coniuge, ossia dalla persona con la
quale condividiamo la nostra casa e in compagnia della quale
trascorriamo molto tempo. Il cerchio interno può anche includere per
un certo periodo i figli, ma il coniuge rimane il referente principale
di questo sangha interno.
2. Quando c’è una buona intesa, le relazioni sono veicoli di unione,
di apertura del cuore, di generosità, di spirito di servizio e di
sacrificio per l’altro. Quanto tutto questo possa riuscire di sostegno
alla pratica è evidente e se ne parlerà. Adesso, invece, consideriamo
anzitutto l’altra faccia della medaglia, ossia il fatto che le
relazioni di coppia sono anche sorgente di avversioni, desideri,
paure. Il vantaggio specifico di una relazione dharmica è questo, che,
in virtù appunto della pratica, tutti questi turbamenti diventano la
materia prima del lavoro interiore per entrambi i coniugi o, comunque,
per il coniuge praticante. Per esempio, è raro che in una relazione
non si nutrano aspettative (consce o inconsce) l’uno nei riguardi
dell’altro: aspettative su come il coniuge deve essere, che cosa è
meglio che faccia, chi deve vedere, come deve parlare, come sarebbe
bene che si vestisse eccetera. Ora queste aspettative, se ci pensiamo,
non sono che espressione di un desiderio di controllare l’altro.
Vedere e comprendere quest’ansia di controllo significa toccare con
mano la nostra possessività e il nostro attaccamento. E significherà
anche avere l’occasione di praticare il lasciare andare, con beneficio
per tutti.
Mi sembra importante, a proposito di tutto ciò, sottolineare che in
una relazione dharmica ci sono due elementi forti, per dir così: il
primo è il reciproco affetto, il secondo è la pratica (di uno solo o
di entrambi i membri della coppia). Ora la somma di queste due cose
moltiplica il potere e l’efficacia del lavoro interiore. Infatti, se
noi lavoriamo a lasciare andare le aspettative riguardo a una persona
cui vogliamo bene, noi oltre a ricorrere alla pratica, attingeremo
naturalmente all’affetto cioè al volere il bene per questa persona e
ciò potenzierà il mio ‘retto sforzo’ di praticante. Inutile dire che
se invece di una relazione fondata sull’affetto si tratta di un
rapporto basato esclusivamente sull’attaccamento, succederà il
contrario: l’attaccamento, infatti, per definizione rafforza le
aspettative.
3. In proposito, vorrei ricordare qualche esperienza personale, anche
se non si tratta di aspettative, bensì di quell’altra forma di
attaccamento che è il desiderio di avere ragione. Mi torna in mente
anzitutto la graduale scoperta, grazie alla consapevolezza, di quanto
sia alienante e isolante la compulsione a privilegiare comunque il
proprio punto di vista: di fatto, una delle manifestazioni più
macroscopiche dell’io/mio e, al tempo stesso, tra le più insidiose,
data la facilità con la quale si presta a razionalizzazioni varie ("Mi
limito ai fatti", "Esprimo l’opinione di molti" eccetera).
Al punto che non è raro imbattersi in cultori seri e appassionati del
Dharma che non si accorgono di tenere l’area in questione
completamente incolta, ossia non appena si profila un confronto di
opinioni, la consapevolezza si eclissa.
Ciò che trovo interessante nella mia esperienza è che questo
attaccamento ad avere ragione diviene molto più tangibile e quindi
‘lavorabile’ allorché io percepisco che durante la discussione anche
mia moglie sta praticando. Questa percezione imprime ulteriore forza
alla mia pratica e sicché la disidentificazione nei confronti
dell’attaccamento al mio punto di vista è facilitata. Infatti
avvertire che anche dall’altra parte c’è lavoro di consapevolezza mi
fa sentire appoggiato e sostenuto. Questo sostegno visto nell’ottica
dell’io è paradossale e incomprensibile. L’unico appoggio
comprensibile per l’ego sarebbe quello di sentirsi dare finalmente
ragione! Ma se siamo praticanti, la percezione di condividere la
pratica in un momento di difficoltà per noi e per l’altro è, in
realtà, un sostegno molto più forte di quello che verrebbe dal
sentirsi dare ragione. Infatti la pratica comune, con l’empatia che
essa produce, si rivela come qualcosa di molto più unificante e
pacificante del consenso a una nostra opinione.
Ancora un esempio sui molti possibili benefici della pratica di
coppia. Al sopravvenire di uno stato mentale negativo, io ero abituato
ad applicare alcune classiche modalità di pratica del Dharma: dalla
consapevolezza di sensazioni fisiche, al respiro cosciente, alla
investigazione dell’identificazione con quello stato, all’evocazione
della metta e delle sue tre sorelle. Quale è stato il contributo della
pratica di coppia? Mi riferisco a quei casi nei quali mia moglie era
al corrente della mia situazione interna. Anche qui: sentire che
mentre io da una parte lavoravo per stare con il mio piccolo
travaglio, dall’altra lei partecipava in virtù di una consapevolezza
empatica aggiungeva vita alla mia pratica. Direi anche che la rendeva
più rilassata e meno austera. Ancora dunque un piccolo duplice
giovamento: per la pratica che diventava più autentica e per la coppia
che si sentiva più unita.
Questi momenti di pratica sortivano effetti molto simili in mia
moglie, come emergeva nei nostri periodici scambi di impressioni e di
riflessioni circa le nostre pratiche individuali e la nostra pratica
di coppia. Questi piccoli ‘seminari’ li continuiamo a fare, perché ci
piacciono e li troviamo utili. Scambiarsi ognuno informazioni sulla
propria pratica, imparare ad avere una percezione della pratica
dell’altro, sentire come l’altro percepisce la nostra pratica sono un
evidente aiuto per la pratica dei due e un buon fermento unitivo per
la coppia. È vero che, negli ultimi tre anni, l’arrivo di un bambino
ha movimentato assai la nostra esistenza, aprendo ovviamente un nuovo
e fondamentale ‘fronte di pratica’. A lungo le ‘sbandate’ da
inesperienza parentale e da persistente mancanza di sonno si sono
sprecate, come suol dirsi. Ora le cose sembrano nettamente cambiate e
c’è, ad esempio, ogni tanto la gioia di vedere la prontezza di
risposta del bambino allorché riusciamo a imbroccare la linea giusta
di pratica davanti a un capriccio.
Un ultimo ricordo personale. All’inizio della relazione di coppia che
mi portò al matrimonio, malgrado le mie intenzioni e i sani principi
non dualistici che esponevo alla mia futura moglie, io in realtà,
facevo ancora un bel po’ di distinzione tra ‘attività dharmiche’ e
‘attività non dharmiche’, e non facevo mistero del mio ‘tifo’ per le
‘attività dharmiche’: meditazione, ritiri, letture giuste eccetera. A
me sembra che, col tempo, proprio in virtù della stessa relazione,
della pratica di coppia, delle consultazioni reciproche sulla pratica,
questo mio atteggiamento dualistico sia prima diminuito e, poi,
utilmente tramontato. Nel venir meno di questa distinzione
artificiosa, rigida e astratta, avrà probabilmente pesato anche la mia
pratica. Ma ho l’impressione che soprattutto la relazione coniugale,
sommata naturalmente alla pratica, abbia sortito un effetto
‘ammorbidente’ per eccellenza, con il conseguente scioglimento di
quella distinzione che, di fatto, era basata su un gratuito giudizio
di valore, non molto dharmico. La buona relazione, così come la buona
pratica, porta pace e distensione e questo giova a superare barriere,
dualismi (di cui quello in oggetto è solo un esempio) e moralismi
tipicamente connessi ad avversione e infelicità.
4. Una relazione dharmica, così come qualsiasi buona relazione,
contribuisce ad alimentare tutto ciò che è accettazione e fiducia. Se
un bambino riceve dai propri genitori dimostrazioni fisiche di
affetto, parole amorevoli e attenzione sollecita, ciò risulterà nello
sviluppo di un senso di fiducia in sé stesso e nel mondo. Ora una
relazione amorevole e ben salda riattiva questa impressione radicale
di accettazione-fiducia. E per coloro che non avessero ricevuto questo
nutrimento nella fanciullezza, una relazione dharmica può talora
riuscire a sviluppare vera accettazione e fiducia per la prima volta
nella vita di una persona.
A questo proposito, ci sono modi specifici per favorire la
cooperazione tra pratica del Dharma e relazione dharmica. Le
tradizionali meditazioni buddhiste di metta, benevolenza, karuna,
compassione, mudita, gioia compartecipe e upekkha, equanimità (ovvero
i quattro brahmavihara), si prestano particolarmente ad accrescere e
approfondire un senso di accettazione-fiducia che sia già presente o
che, comunque, aspiri a svilupparsi. A me sembra che l’invio di
pensieri amorevoli ricorrendo alle frasi specifiche di metta, quali:
"Che tu possa essere in buona salute, felice, al sicuro dai pericoli",
o altre equivalenti, dovrebbe essere la pratica di fondo in una
relazione. Nel mio caso, oltre a indirizzare la metta a mia moglie e a
nostro figlio nella vita quotidiana, nei miei ritiri personali,
impiego una fase della giornata a coltivare metta nei loro confronti.
È molto da incoraggiare, io credo, in un praticante di Dharma il
ricorso pronto alla pratica di karuna o compassione allorché vediamo
che il nostro coniuge soffre, oppure la coltivazione di mudita, gioia
compartecipe, allorché lei/lui appare rallegrarsi per qualche motivo.
Infine, come in tutto, così anche nella relazione, è superfluo dire
quanto sia centrale e cruciale la pratica dell’equanimità, upekkha,
cuore degli altri brahmavihara (che non possono raggiungere la piena
autenticità in mancanza di upekkha) e cuore della stessa
consapevolezza, non a caso definita attenzione non giudicante. Nella
relazione di coppia si tratterà di affrontare insieme le difficoltà
della vita coltivando la spaziosità feconda dell’equanimità. E di
affrontare le difficoltà inerenti alla stessa relazione cercando da un
lato di capire e di comunicare il più possibile, dall’altro senza
stancarsi di coltivare l’equanimità (talora con frasi mentali del
tipo: "Che io possa accettare noi due così come siamo" e simili):
questo è fondamentale per la prosperità della relazione ed è
fondamentale come cammino verso la liberazione.
Osserviamo che la pratica della gioia compartecipe, mudita ("Che la
tua gioia possa durare il più possibile") è un indice piuttosto
preciso del grado di salute di una relazione. Se ci accorgiamo che
siamo distratti e assenti davanti alle piccole soddisfazioni del
nostro coniuge o anche semplicemente davanti al suo buon umore e se,
di conseguenza, perdiamo spesso l’occasione di partecipare alla sua
gioia, ciò significherà che noi stiamo privando noi stessi e il nostro
coniuge di una fonte di benessere. In questo caso mi sembra
imperativo, se teniamo alla nostra relazione, di investigare a fondo i
motivi di questa nostra distrazione.
Parlando di pratica di coppia sarebbe strano non accennare alla
sessualità. Ci occuperemo più avanti del terzo precetto, relativo alla
fedeltà coniugale. Ora vorrei considerare brevemente la questione
della sessualità in relazione alla pratica di metta, questione sulla
quale mi pare opportuno spendere qualche parola. Nella tradizione
buddhista Theravada i praticanti sono incoraggiati a non mandare metta
all’indirizzo di persone verso le quali hanno un’attrazione sessuale.
Infatti l’attrazione sessuale è definita il ‘nemico prossimo’ della
metta. Prossimo, vicino, perché può essere scambiato erroneamente per
metta. Sicché possiamo essere convinti di praticare metta laddove, in
realtà, stiamo alimentando l’attaccamento, che è una forza egocentrica
e non già benevolenza universale incondizionata o, per lo meno, una
forte tendenza in questa direzione.
Ora, a me pare che mentre queste istruzioni sono ineccepibili riguardo
a monaci e monache votati alla castità, le cose siano più complesse
quando si tratta di laici. In primo luogo credo che, se siamo adulti,
dovremmo essere in grado di distinguere chiaramente tra desiderio
sessuale e sollecitudine, cura, benevolenza e saremo perciò
naturalmente capaci di accantonare il primo e coltivare le seconde. In
secondo luogo, una volta accertata questa capacità di discernimento,
perché mai non dovremmo infondere la metta anche nella sessualità?
Perché questa eccezione? E, soprattutto, quale sarebbe per un
praticante l’alternativa? Invece chiunque ha fatto in modo di
estendere la metta alla sessualità con una certa costanza e per un
periodo di tempo sufficientemente lungo, sa bene che i tipici effetti
della metta, prima o poi, si fanno sentire: la sessualità diventa meno
compulsiva e possessiva da un lato e più gentile, delicata e oblativa
dall’altro.
5. Abbiamo visto che le meditazioni di metta, karuna, mudita e upekkha
sono modalità di pratica specialmente fruttuose nell’ambito delle
relazioni. Un’altra modalità è quella di coltivare la consapevolezza
di tutto quello che è non accettazione, resistenza o mancanza di
fiducia nella relazione. Ossia portare la consapevolezza su forme di
sofferenza specifiche della relazione: ed è superfluo dire che questa
è in genere, un’area di lavoro piuttosto ricca. Infatti, anche nella
relazione più armonica di questo mondo, è assai improbabile che non ci
siano, per esempio, un certo numero di "non mi piace" reciproci,
magari piccoli, riguardo a modi di pensare, di agire e di parlare del
coniuge. Di nuovo, l’amore che lega la coppia offre uno straordinario
sostegno alla nostra stessa pratica, pratica che, per essere
autentica, va mirata anzitutto alla nostra reattività, anche se la
nostra reattività è tenue e modesta. C’è una riflessione che
personalmente ho sempre trovato specialmente utile (e non è limitata
al campo delle relazioni intime) davanti a comportamenti compulsivi
altrui che io tendo a giudicare e stigmatizzare. Ossia riflettere sul
fatto che la mia reazione giudicante è per lo meno altrettanto
ripetitiva, prevedibile e compulsiva. E ciò indica con insuperabile
chiarezza che entrambi soffriamo della stessa malattia, sicché
l’atteggiamento più appropriato e più consono alla pratica del Dharma
sarà quello di generare un’energia benedicente e compassionevole verso
l’altro e verso noi stessi.
Santideva, il poeta buddhista indiano dell’8° secolo, osserva che se
qualcuno ci colpisce con un bastone, noi certamente non ce la
prenderemo col bastone 3. Ce la prenderemo, invece, con chi ha mosso
il bastone. Eppure, dice Santideva, così come il bastone è stato
mosso, allo stesso modo anche il bastonatore è stato mosso da un
insieme di cause e condizioni. Se non ce la prendiamo col bastone
perché è manovrato da qualcuno, perché vogliamo prendercela con chi è
altrettanto manovrato da tutto un condizionamento? Nel nostro caso, il
comportamento del nostro coniuge e la nostra reattività ad esso sono
entrambi frutto di condizioni. Percepire con chiarezza questa
condizionalità e riflettere sul suo potere non può che intensificare
la comprensione e la compassione nell’ambito della coppia.
In tal modo, appoggiati a una base di compassione, noi saremo in grado
di focalizzare più agevolmente consapevolezza e chiara comprensione su
tutte quelle aspettative e quei concetti che noi alimentiamo riguardo
al nostro coniuge e che sono responsabili del ciclo
attaccamento-frustrazione e non accettazione in certe aree della
nostra relazione. E ciò avrà come frutto un bellissimo regalo per il
coniuge e per noi stessi, vale a dire un drastico calo della nostra
reattività e della nostra dipendenza dalle aspettative.
A questo proposito, vorrei sottolineare che il nostro atteggiamento
riguardo ai piccoli difetti del coniuge è un campo di pratica da non
sottovalutare. A causa dell’affetto reciproco, infatti, ci accadrà
facilmente di passare sopra cose del genere. Il che può andare
benissimo, a patto che non implichi la repressione delle nostre
piccole reazioni a quei difetti, repressione che non è certo pratica
del Dharma. Una buona idea, invece, sarà quella di lavorare anche con
queste nostre ‘mini-reazioni’. Cosicché disporremo di un campo di
training relativamente facile e, al tempo stesso, efficace. Va da sé
che se sviluppiamo una certa abilità in questa sfera, ci ritroveremo
poi molto meglio equipaggiati nel caso di turbamenti più gravi.
D’altra parte, anche qui non mi sembra che ci sia alternativa: il
cammino dello sviluppo interiore procede in virtù del fronteggiare
sfide prima piccole o minime e quindi via via più grandi. E dobbiamo
ricordarci che la situazione che noi abbiamo in una relazione dharmica
è una situazione insolita e paradossale. Infatti da una parte ci sono
anni, forse decenni, di vita comune, che vuol dire una certa facilità
a cadere nell’abitudinario e nel meccanico. Dall’altra parte,
tuttavia, noi disponiamo – è qui il paradosso – di quella freschezza e
di quella prontezza che sono tipicamente generate dalla pratica del
Dharma potenziata dall’affetto reciproco e dal nostro sostenere con
tutto il cuore l’uno la pratica dell’altro. Sarebbe un peccato non
avvantaggiarsi di una situazione così unica. E ciò ricorrendo a un
atteggiamento che a me viene da chiamare di tenera implacabilità. In
questo mossi non già da qualche empito perfezionistico, bensì,
piuttosto, dalla comprensione che senza una determinazione ferma e
gentile a lavorare con qualsiasi zona d’ombra nella relazione, sono in
pericolo sia la relazione sia, in qualche modo, la nostra pratica del
Dharma.
6. Torniamo adesso a quanto si diceva circa la possibilità che l’un
coniuge sia maestro all’altro. Infatti, soprattutto se siamo in
presenza di una lunga e buona relazione, ciascun coniuge conosce molto
bene le debolezze e i punti di forza dell’altro. Talora ancora meglio
dell’interessato! In questo senso un coniuge ha la potenzialità di
essere l’insegnante più affidabile per l’altro. Però a una condizione
che non è immediatamente accessibile: un bel po’ di affettuosa
equanimità. Se è presente questa virtù, allora la devozione per il
Dharma consentirà ai coniugi di essere specchio l’uno all’altro,
corroborando in tal modo l’intenzione di risvegliarsi il più possibile
al momento presente. Così, per esempio, essere specchio fedele
dell’indebolirsi della motivazione alla pratica nel nostro coniuge
sarà probabilmente un insegnamento molto efficace. Tuttavia, senza una
buona dose di affettuosa equanimità, "essere uno specchio" si ridurrà
a una sorta di pseudo-imparzialità, di fatto trasudante un chiaro
spirito di censura, al di là delle nostre migliori intenzioni. E
naturalmente ciò non potrà che incrementare la mancanza di motivazione
nell’altra persona.
Nibbida, ovvero il sereno disincanto davanti alle lusinghe
dell’avversione e dell’attaccamento (ricordando che il carattere
‘seducente’ dell’attaccamento e dell’avversione è un aspetto
dell’ignoranza) è un grande punto di svolta nel cammino di
liberazione. Nei Sutta del Buddha è frequente una formula che indica
come nibbida sia il presupposto più importante del non attaccamento
(viraga) e questo, a sua volta, sia il fondamento della liberazione 4.
Nibbida è come dire una stanchezza nuova e promettente. È quando,
infatti, cominciamo a essere stanchi di alimentare gli inquinanti
mentali, stanchi di regalare tanta energia all’identificazione e al
sistematico potenziamento della mente giudicante. D’altra parte questa
‘stanchezza’ è frutto di una lenta infiltrazione di saggezza nella
mente-cuore e dunque, lungi dall’essere un qualcosa di opprimente, si
manifesta, piuttosto, come una liberatoria leggerezza.
Ora, in merito all’argomento della coppia, mi sembra che la nibbida
abbia implicazioni cruciali, dato che significherà, ovviamente, un
felice disincanto davanti all’idea di essere infedeli al nostro
coniuge. Naturalmente anche una buona relazione non garantisce la
fedeltà, solo la rende più facile. Ci sono occasioni nelle quali è
necessario fare appello a tutta la nostra determinazione per rimanere
fedeli al coniuge e al terzo precetto. Osserviamo, riguardo a
quest’ultimo, e in generale, a tutti i precetti, che lunghi anni di
dedizione alla pratica rendono i precetti, così come la nibbida, molto
più significativi. Anni di pratica approfondiscono la comprensione dei
precetti in una maniera molto naturale, tanto che a un certo punto
cominciamo a sentirli non soltanto come norme poste a garanzia di
civiltà di vita, ma soprattutto come espressioni viventi di saggezza.
Dunque, dopo una certa maturazione della pratica, i precetti si
caricano di una qualità e di una profondità che, in genere, non
possono avere all’inizio della pratica, allorché essi sono ‘soltanto’
precetti. Quanto alla nibbida, essa all’inizio, salvo eccezioni, non
esiste poiché, anzi, predomina il suo contrario, l’incantesimo
dell’io/mio. Ma se noi continuiamo a praticare, la nibbida prima o poi
emergerà e – cosa rilevante – ci accorgeremo che essa opera
sinergisticamente con i precetti.
Tornando al terzo ‘precetto di addestramento’ 5, che è quello relativo
alla fedeltà coniugale, se all’inizio esso sarà l’ovvio custode della
relazione, col tempo, in consonanza con quell’approfondimento di cui
si è detto, dovrà diventare, soprattutto, l’offerta di un impegno. E
quando l’impegno si fa difficile, l’offerta, seppure travagliata,
dovrà avere il gusto della generosità più che la stretta del rigore.
Va da sé che una qualche misura di nibbida è l’ingrediente centrale di
questa trasformazione. Aggiungiamo che, nell’ambito delle relazioni,
nibbida implica un apprezzamento non superficiale di quello che già
abbiamo, apprezzamento che scoraggia eloquentemente e silenziosamente
movimenti distruttivi. Nibbida nasce da una stagionata familiarità con
la mente ‘non lavorata’, che è costituzionalmente irrequieta e avida
di accumulare nuove esperienze, e la nibbida comincia a manifestarsi
come crescente sfiducia nella ‘ragionevolezza’ accampata dai nostri
attaccamenti, incluse proliferanti spinte centrifughe rispetto alla
relazione.
7. A conclusione di queste riflessioni succinte su un tema che merita,
io credo, di essere costantemente tenuto presente, discusso e
approfondito, se crediamo nella possibilità del radicamento di una
forte spiritualità laica (e non soltanto buddhista) nel mondo
contemporaneo, ancora tre ultime annotazioni.
La prima è che la relazione dharmica, a mano a mano che diventa più
salda e intima, prende a suscitare un vero e proprio spirito di
devozione, devozione che – verrebbe da dire – chiede essa stessa di
essere coltivata: è devozione – ovvero sollecitudine senza riserve –
per il coniuge, è devozione per la relazione, ossia un desiderio
crescente di prendersene cura, è devozione al Dharma, la cui pratica
arricchisce noi e la relazione.
In secondo luogo osserviamo che gli effetti benefici di qualsiasi
buona relazione è come se chiedessero di espandersi oltre i confini
della coppia, in una aspirazione che potrebbe formularsi con queste
parole: "Così come io sono cresciuto/a grazie all’amore, alla
comprensione e all’accettazione del mio coniuge e così come il mio
coniuge è cresciuto/a grazie al medesimo atteggiamento proveniente da
me, possa questo amore, questa comprensione e accettazione espandersi
oltre i confini della nostra relazione".
La terza annotazione è questa. Se è vero che questo scritto concerne
specificamente la relazione di coppia, è d’altra parte anche vero – e
sembra importante sottolinearlo – che una buona parte, anche se non
tutta, di quanto si è detto può essere applicata a qualsiasi tipo di
relazione, e dunque relazioni di amicizia, di parentela, o, in certi
casi, di lavoro. L’altro, praticante o meno, come invito alla
comunicazione, all’onestà di parola e di azione, al servizio per il
suo benessere, alla generosità e alla condivisione; e l’altro,
naturalmente, come invito a incontrare e curare noi stessi, a
cominciare da tutta la conflittualità, la reattività, l’avversione o
l’attaccamento possessivo che l’altro ci può suscitare. Per capire
forse un giorno che la distinzione tra me e l’altro non può che venir
meno nell’intuizione della sacralità della vita, che al praticante si
rivela sempre più come la cosa più reale.
Note
1. In questo scritto la parola ‘coniuge’ indica chiunque sia impegnato
seriamente in una relazione di coppia, e non solo chi è ufficialmente
sposato.
2. A. Desjardins, Toward the Fullness of life, Putney and Brattelboro,
Vermont 1990, p. 146; ed. orig. Pour une vie reussie, Paris 1987;
trad. it. Per una vita riuscita, Perla ed., Grosseto-Milano, s. d.
3. Santideva, Bodhicaryavatara, Oxford University Press, 1996, cap.
6°, strofe 41, p. 53. Ed. ital. Ubaldini, Roma 1998, p. 85
4. P. es. Samyutta-Nikaya 35, 28.
5. Così Bhikkhu Bodhi autorevolmente traduce sikha, in genere reso
semplicemente con ‘precetto’.
|
|
![[AmadeuX BiblioForum] [AmadeuX BiblioForum]](https://www.amadeux.it/forum/immagini/amadeuxcomm1.jpg)