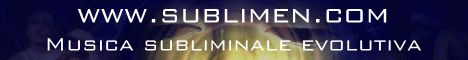| V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
| admin |
Inserito il - 03/03/2011 : 10:37:13
L'inquisizione: il tribunale dell'anima
di Paolo Fezzi
L'Inquisizione e' tornata a essere un argomento d'attualita' dopo le
dichiarazioni critiche del papa sugli errori commessi dalla Chiesa in
passato e la decisione, nel gennaio 1997, di aprire gli archivi segreti del
Santo Uffizio all'indagine degli storici.
Cenni storici
L'Inquisizione e' un tribunale ecclesiastico, creato nel Medioevo per
giudicare il reato di eresia: il primo nucleo fu istituito nel 1184 da papa
Innocenzo III, per combattere l'eresia dei catari, che si era diffusa nella
Francia meridionale, costituendosi come chiesa autonoma, dotata di propri
vescovi. Nata come strumento d'emergenza, fu istituzionalizzata da Gregorio
IX, che nel 1231 ne fisso' l'organizzazione e le regole, e nel 1236 affido'
l'incarico di Inquisitori ai membri dell'ordine domenicano, da poco
istituito. Nel Trecento la procedura del tribunale fu rigorosamente
definita in specifici trattati, tra i quali ricordiamo il Directorium
inquisitorum (1376) di Niccolo' Eymerich e la Practica inquisitionis (1320)
di Bernardo Gui, reso famoso dal romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco.
Un tribunale cosi' potente si prestava ad essere utilizzato come strumento
di lotta politica: famoso e' il caso di Giovanna d'Arco, condannata per
eresia nel 1431, nel corso della Guerra dei Cento Anni tra Francia e
Inghilterra, da un Inquisitore fedele agli inglesi.
Nel Trecento, dopo la sconfitta delle principali eresie medievali, la
giurisdizione dell'Inquisizione si estese al reato di stregoneria,
equiparata all'eresia nel 1326 dal papa Giovanni XXII, con la bolla Super
Illius specula: dal Trecento al Seicento l'Inquisizione fu impiegata cosi'
nella persecuzione sistematica di streghe, maghi, indovini, tutti accusati
di aver stretto un patto col diavolo. Fiori' a riguardo una ricca
letteratura demonologica e antistregonica, della quale ricordiamo il
Formicarius (1437) del tedesco Nider, il Tractatus contra deamonum
invocatores (1483) del francese Vineti e, soprattutto, il Malleus
Maleficarum (Martello delle Streghe) scritto nel 1486 dai domenicani
tedeschi Sprenger e Institoris, il trattato piu' organico e sistematico
sull'argomento.
Un carattere particolare ebbe la cosiddetta Inquisizione spagnola, detta
anche Suprema Inquisizione (o semplicemente Suprema), tribunale speciale
nato nel 1478 per punire gli Ebrei e i Mori che, convertiti al
cristianesimo, praticavano in segreto la loro religione. Famosa per
l'estrema intransigenza dei suoi giudici (tra i quali rimase leggendaria la
figura di Tommaso Torquemada), l'Inquisizione spagnola si distingue da
quella ecclesiastica per essere alle dirette dipendenze del potere
politico, strumento di governo dei re di Spagna: l'imposizione dell'unita'
religiosa ai propri sudditi fu spesso il pretesto per affermare ovunque
l'autorita' monarchica ed eliminare le autonomie locali. Per questi motivi
la Suprema era temuta non solo dalle sue vittime, ma da tutti i nobili e i
cittadini delle regioni periferiche dell'impero spagnolo, gelosi dei propri
privilegi e delle loro residue autonomie: in Italia il Ducato di Milano e
il regno di Napoli si opposero piu' volte con successo alla sua
introduzione nei propri territori e il tentativo di adottarla nei Paesi
Bassi provoco' una sollevazione generale, che porto' all'indipendenza della
nazione olandese.
Nel 1542 il papa Paolo III, con la bolla Licet ab initio, decise di
adottare l'Inquisizione contro l'eresia protestante, luterana e calvinista:
benche' ci fossero molti elementi di continuita' con l'Inquisizione
medievale, si tratto' per molti aspetti di un'istituzione nuova, detta
dagli storici Inquisizione romana, per distinguerla dal suo antecedente
medievale e dalla coeva Inquisizione spagnola. In particolare acquisi' una
struttura piu' centralizzata, alle strette dipendenze del papa: la sua
direzione fu infatti affidata alla Congregazione del Santo Uffizio, una
commissione composta da un numero ristretto di cardinali (da quattro a
sei), regolarmente presieduta dal papa e in continuo contatto con i
tribunali periferici tramite una fitta corrispondenza. La Congregazione del
Santo Uffizio aveva il controllo su tutte le altre congregazioni
cardinalizie e un potere senza limiti, non solo sui comuni credenti, ma
anche su vescovi e cardinali. Ricordiamo ad es. l'incriminazione per eresia
dell'inglese Reginald Pole (1558) e dell'italiano Giovanni Morone
(1557-1560), tra i piu' aperti cardinali dell'epoca. Per ben tre volte, nel
Cinquecento, il papa fu scelto tra gli Inquisitori del Santo Uffizio: il
primo fu Gian Pietro Carafa (papa Paolo IV), potente cardinale che ebbe un
ruolo decisivo nella riorganizzazione dell'Inquisizione; segui' quindi
Michele Ghislieri, umile frate di Como, che grazie al ruolo di Inquisitore
fece una brillante carriera, fino a diventare papa Pio V; infine Felice
Peretti che, con il nome di Sisto V, defini' minuziosamente la struttura
burocratica delle congregazioni cardinalizie.
L'Inquisizione romana, giudicata dagli storici l'unica istituzione centrale
efficiente, nella frammentazione politica dell'Italia del tempo, celebro' i
famosi processi contro Giordano Bruno, condannato al rogo nel 1600, e
Galileo Galilei, costretto all'abiura nel 1633.
Se l'Inquisizione, come tribunale ecclesiastico formalmente definito, e' un
fenomeno esclusivamente cattolico, l'inquisizione, intesa in senso ampio
come procedimento giudiziario in materia di fede, fu un metodo ampiamente
adottato, nel Cinquecento e nel Seicento, anche dai protestanti, luterani e
calvinisti, nei confronti di anabattisti e liberi pensatori: tristemente
famoso e' il caso di Michele Serveto, umanista spagnolo, condannato nel
1553 al rogo da un tribunale di Ginevra, su accusa dello stesso Calvino.
Nel Settecento, sotto l'influsso della cultura illuminista, in molti Stati
europei l'Inquisizione fu espulsa o limitata nelle sue funzioni. La
Congregazione del Santo Uffizio, ridotta dalla secolarizzazione a semplice
strumento interno alla Chiesa, con il Concilio Vaticano II ha assunto la
denominazione di Congregazione per la dottrina della fede (7 dicembre
1965), mantenendo le sue competenze in materia di fede e morale.
Eresia e sovversione: il braccio secolare
Per la mentalita' moderna e' difficile capire come si possa condannare a
morte un individuo per una convinzione personale in materia di fede. Ma
l'eresia, definita da Tommaso d'Aquino "errore dell'intelletto cui la
volonta' ostinatamente aderisce", nelle societa' cristiane premoderne, dal
Medioevo fino al Settecento, era una questione non solo di fede, ma anche
di ordine pubblico: religione e politica, Chiesa e Stato erano strettamente
connessi e la fede aveva una rilevanza sociale e politica, che riguardava
l'intera collettivita', non solamente l'interiorita' dell'individuo.
Infatti, nel diritto dell'epoca, Dio era la fonte di qualsiasi potere e non
solo il re era tale per grazia di Dio, ma la fede in Dio e la lealta'
feudale nei confronti del proprio sovrano erano non a caso espresse con la
stessa parola, fides: un luogo comune ripetuto dagli Inquisitori era che
non puo' essere fedele agli uomini chi ha violato la fede data a Dio.
All'inizio del Duecento una serie di decreti papali e imperiali,
rifacendosi al Codice di Giustiniano, affermarono solennemente
l'equiparazione tra l'eresia e il delitto di lesa maesta': in altre parole
l'eresia e' ritenuta una forma di sovversione e di ribellione al potere
politico. Di conseguenza da un lato re e principi laici (ad es. i re di
Spagna, ma anche occasionalmente i re di Francia e di Inghilterra) hanno
affermato il diritto di giudicare i propri sudditi su questioni di fede,
dall'altro il papato ha formulato la teoria del braccio secolare, secondo
la quale spetta alla Chiesa, in quanto depositaria dell'ortodossia in
materia di fede, il giudizio sugli eretici, mentre la loro punizione
materiale e' delegata al potere civile (imperatore, re, duca, autorita'
cittadina ecc.). Questa teoria, che ha ispirato per secoli la pratica
dell'Inquisizione, dal Medioevo alla Controriforma, si e' imposta quasi
ovunque per l'interesse comune delle autorita' religiose e politiche ad
appoggiarsi a vicenda per meglio conservare il proprio potere. La sua
applicazione creava talvolta tensione tra Chiesa e potere politico, spesso
richiedeva complesse trattative diplomatiche tra il rappresentante del papa
e l'autorita' civile, ma raramente quest'ultima si rifiutava di eseguire la
condanna decisa dall'Inquisizione: non solo infatti il rifiuto implicava
l'accusa di complicita' con l'eretico, ma qualsiasi minaccia al potere
ecclesiastico era percepita come minaccia alle basi del potere politico.
Tribunale della coscienza: dall'eresia alla devianza
La peculiarita' dell'Inquisizione, che la distingue dagli altri tribunali,
e' nel suo essere un tribunale della coscienza: "cio' che essa giudica sono
propriamente le opinioni delle persone, le idee, le credenza, la fede; in
una parola l'inquisitore giudica l'anima di chi e' sotto processo" (Benazzi
- D'Amico Il Libro Nero dell'Inquisizione, pag. 16). È questa propensione a
rendere pubblico il privato, a indagare e controllare l'interiorita' degli
individui, senza il loro assenso e contro la loro volonta', che scandalizza
la coscienza moderna, in quanto attacca le radici stesse della liberta'
individuale:
Nel momento in cui un tribunale esterno [S] pretende di "avere diritto"
sulla coscienza personale, ecco che all'uomo non resta piu' alcun luogo
segreto da preservare: egli e' completamente nudo di fronte al suo
avversario.
L'Inquisizione si fa carico proprio di questo compito: "guardare dentro",
nel luogo piu' recondito dell'uomo [S]; l'Inquisizione non svela soltanto
il delitto, ma l'anima del delittuoso, la mette in piazza, la consegna al
popolo, ai vicini di casa, ai nemici e, cosa forse ancora piu' tremenda,
agli amici. (Benazzi - D'Amico op. cit., pag. 126).
Essendo l'Inquisitore un giudice dell'anima, il fine della sua indagine non
si arresta all'accertamento della verita', come nei tribunali ordinari, ma
si spinge fino a ottenere la confessione e il pentimento dell'imputato,
saldando in un unico ruolo funzioni che siamo abituati a tenere distinte:
quelle del giudice, del pubblico ministero, dell'avvocato e del confessore.
Indagando non solo l'azione, ma anche l'intenzione che la motiva,
l'Inquisizione ha esteso progressivamente la sua giurisdizione dall'eresia
formale ed esplicita a tutte le forme di eresia implicita, e quindi a tutti
i comportamenti che implicano la possibilita' di convinzioni eretiche, come
la bestemmia, che puo' non essere semplicemente un peccato, ma nascondere
convinzioni erronee ed eretiche sulla natura di Dio. Su questa strada
l'azione degli Inquisitori si e' gradualmente spostata dal campo dottrinale
a quello morale, dalla punizione dell'eresia alla sistematica persecuzione
di qualsiasi forma di devianza rispetto alle norme morali, occupandosi di
bestemmia, sodomia, bigamia, ecc.. Lo storico Bartolome' Bennasar, in
un'accurata indagine quantitativa sui processi dell'Inquisizione spagnola,
ha rilevato a questo proposito che nel periodo tra il 1530 e il 1630 la
maggioranza dei procedimenti ha avuto per oggetto casi di "parola erronea",
termine che per gli Inquisitori includeva bestemmie ed espressioni oscene.
Al di la' delle sue motivazioni iniziali, l'Inquisizione e' stata percio'
usata sempre piu' spesso come strumento di disciplina e di rieducazione dei
comuni credenti, imponendo a tutti un unico modello di comportamento, con
l'effetto di promuovere il conformismo sia sul piano teorico sia su quello
pratico.
Il metodo dell'Inquisizione: violenza fisica e psicologica
In conformita' al diritto penale del tempo la procedura dell'Inquisizione
si basava sulla presunzione di colpevolezza dell'imputato e la legittimita'
della tortura come strumento di prova: con l'aggravante che la negazione
sotto tortura poteva essere interpretata dal giudice come impenitenza,
cioe' colpevolezza recidiva. In base al presupposto che l'eretico e' per
definizione ingannatore e in mala fede, la strategia processuale
dell'Inquisitore era improntata a un sospetto sistematico, alla luce del
quale qualsiasi persona era esposta al rischio di essere inquisita e
qualsiasi risposta dell'imputato era interpretata con diffidenza.
Coerentemente con queste premesse l'Inquisitore ricorreva costantemente
alla delazione: infatti il procedimento inquisitoriale poteva nascere non
solo da un'esplicita accusa (accusatio), ma anche da una denuncia anonima
(denunciatio) e addirittura dal ripetersi di pubbliche voci (fama). E da
parte sua l'Inquisitore incoraggiava la delazione con ogni mezzo: giunto
nella localita' a lui affidata, con una pubblica predica intimava a tutti
gli abitanti di denunciare i fatti a loro conoscenza, promettendo
l'indulgenza a chi lo avrebbe aiutato e minacciando di scomunica chi non
obbediva al suo ordine di delazione.
Un'altra peculiarita' dell'Inquisizione era la segretezza della sua
procedura: l'imputato era tenuto all'oscuro dell'accusa fino al momento di
comparire di fronte al giudice e potevano passare mesi, tra l'arresto e la
convocazione; in seguito egli non aveva alcun diritto a prendere visione
delle testimonianze, che gli erano lette a discrezione del giudice, senza
mai comunicargli i nomi degli accusatori; l'imputato era inoltre rinchiuso
in un carcere che garantiva il suo completo isolamento, per mesi o anni;
infine gli atti processuali non erano resi pubblici neanche alla fine del
procedimento, ma inviati a Roma, dove erano custoditi in archivi riservati.
Fin dalla prima udienza l'Inquisitore iniziava un gioco complesso, di cui
conduceva sempre le fila e la cui regola fondamentale era che solo il
giudice puo' fare le domande e l'imputato deve rispondere. La prima
domanda, se l'imputato fosse al corrente del motivo per cui era stato
convocato, metteva subito in chiaro che l'Inquisitore sapeva gia' tutto e
che non restava altra via che confessare. Quindi, con ulteriori domande, il
giudice spingeva discretamente l'imputato a parlare del reato specifico di
cui era accusato. Eymerich nel suo trattato invitava l'Inquisitore a ogni
possibile astuzia per far confessare l'imputato: Francisco Peña, nel suo
commentario, precisava che era tuttavia disdicevole dire bugie. Tutti i
trattati elencavano minuziosamente le regole per decifrare e controbattere
le menzogne e le risposte elusive dell'imputato.
Due testimoni "singoli", cioe' parzialmente concordi nella loro
testimonianza, avevano valore di prova, ma l'elemento probatorio
fondamentale era la confessione, necessaria inoltre per la riabilitazione
dell'accusato: per ottenerla era lecito sottoporre l'imputato a tortura.
Alcuni storici hanno minimizzato l'incidenza della tortura nei processi
dell'Inquisizione, affermando che era utilizzata molto meno che nei
tribunali civili dell'epoca. Bisogna tuttavia precisare che spesso, per
indurre alla confessione, era sufficiente la minaccia della tortura (e' il
caso ad es. di Giovanna d'Arco). E oltre alla violenza fisica, gli
Inquisitori facevano un uso assai sottile della violenza psicologica,
evidente non solo nella segretezza della procedura, ma anche nella sapiente
alternanza di minacce e blandizie, di ore di tortura e parole
compassionevoli.
Per capire la natura di questa violenza giovera' un breve accenno alla
teoria del doppio vincolo di Gregory Bateson: il doppio vincolo e' una
situazione relazionale in cui una persona sottopone un'altra a due
ingiunzioni tra loro in contraddizione, ad es. "Se farai cosi', io ti
puniro'" e "Non considerare cio' come una punizione", rinforzate da una
terza ingiunzione che rende il conflitto insolubile, ad es. "Se non farai
cosi', ti puniro' ugualmente". Spesso la relazione tra Inquisitore e
inquisito assumeva questa forma, ad es. quando il giudice affermava di
torturare la vittima per il suo bene; o quando avvertiva l'imputato che
rifiutandosi di confessare dimostrava ancora di piu' la sua colpevolezza
(la mancata confessione era infatti un indizio di ostinazione e
impenitenza). Secondo Bateson il doppio vincolo ha un effetto
destrutturante e distruttivo sulla psiche di chi lo subisce, lasciandolo in
una situazione di completo disorientamento, da cui possono nascere sindromi
schizofreniche. Dalle testimonianze storiche emerge in effetti come
l'imputato arrivasse a confessare in seguito a una condizione di totale
incertezza e profonda crisi d'identita'.
A chi confessava e si pentiva era concesso il perdono: l'imputato, dopo
esser sottoposto a una pubblica abiura dei suoi errori (in Spagna chiamata
autodafe'), era rilasciato e condannato a semplici penitenze, come
preghiere o pellegrinaggi. Ma per essere accreditati come pentiti spesso
non era sufficiente una generica confessione: erano necessari riferimenti
precisi, con i nomi dei complici.
In caso di condanna a morte, l'esecuzione era delegata all'autorita'
civile, con la preghiera di non usare troppa durezza: in realta' la
richiesta era meramente formale e chi avesse osato risparmiare il
condannato avrebbe rischiato l'accusa di complicita'. La scelta del rogo
aveva lo scopo di risparmiare al clero giudicante l'accusa di spargimento
di sangue, in conformita' con la legge mosaica che vieta i sacrifici umani.
Oltre alla morte erano previste anche la prigione, la confisca dei beni e
il marchio di infamia (ad es. tuniche colorate da portare per tutta la
vita). Il carattere pubblico della pena, qualunque essa fosse, era il
fulcro di una vera e propria pedagogia del terrore, che aveva lo scopo di
dissuadere le masse dal comportamento condannato.
Ideologia e personalita' degli Inquisitori
Gli Inquisitori respingevano le accusa di crudelta', rivolte loro anche da
vescovi cattolici: papa Paolo IV, uno degli artefici dell'Inquisizione
romana, ebbe a dire, del Santo Uffizio, che procedeva "con molta pieta' et
misericordia, et che se si peccava, si peccava in esser troppo miti". Gli
Inquisitori si sentivano investiti di una missione superiore, affidata loro
da Dio, e la punizione dell'eretico aveva per loro lo scopo di salvare
l'anima sua e di tutti coloro che egli poteva contaminare, con le sue idee
errate. Il senso di una missione da compiere spingeva alcuni Inquisitori a
esporsi al martirio e nel 1252 uno di loro, Pietro da Verona, lo subi'
effettivamente. Intransigenti, inflessibili, incorruttibili, affermavano di
essere animati non da animosita' personale, ma da un "odio santo e
perfetto" nei confronti dell'eresia e del male. Non solo non avvertivano
alcuna contraddizione tra la violenza di cui si macchiavano e lo spirito
dei Vangeli, ma strumentalizzavano spregiudicatamente passi del Nuovo
Testamento per giustificare l'uso della forza in materia di fede.
I limiti del revisionismo cattolico
Papa Giovanni Paolo II, dopo aver ammesso che il processo a Galileo Galilei
e' stato un errore (10 novembre 1979), e dopo aver aperto agli storici gli
archivi del Santo Uffizio (gennaio 1997), il 19 novembre 1998, durante una
visita alla Repubblica Ceca, ha chiesto pubblicamente scusa per i crimini
commessi, durante la Controriforma, dalla Chiesa cattolica contro i
protestanti. Si dice che il Giubileo del 2000 sara' l'occasione per una
pubblica ammenda del papa per tutte le vittime dell'Inquisizione. Questo
pentimento, anche se tardivo, della Chiesa cattolica, e' senza dubbio
apprezzabile, ma non puo' non suscitare qualche perplessita'. I due
studiosi cattolici, autori de Il Libro Nero dell'Inquisizione, Natale
Benazzi e Michele D'Amico, con molta onesta' pongono la questione
fondamentale: "La violenza fisica non esiste piu', ma quella morale ed
interiore e' completamente scomparsa dai tribunali (non scomparsi)
ecclesiastici? La Chiesa che chiede perdono per quella Inquisizione, e' una
Chiesa che ha scelto di non inquisire piu'?"
La condanna per eresia di Luigi Lombardi Vallauri, professore di Filosofia
del Diritto all'Universita' Cattolica di Milano, nel novembre 1998 (quasi
contemporaneamente alle scuse del papa per gli errori passati), e' una
prima risposta negativa a questa domanda. Vallauri, processato dalla
Congregazione per la dottrina della fede per aver messo filosoficamente in
dubbio l'eternita' dell'inferno, non ha perso la vita o i suoi beni, ma
solo il suo incarico di professore universitario. Qualcosa e' cambiato, ma
la segretezza della procedura, senza possibilita' di contraddittorio,
ricorda l'antica Inquisizione. C'e' dunque da chiedersi a cosa esattamente,
dei suoi passati metodi, intenda rinunciare la Chiesa: all'uso della
violenza per la conversione delle anime? In tal caso la Chiesa rinuncia a
un'arma che le e' gia' stata tolta dall'evoluzione storica, cioe' dalla
secolarizzazione e dalla trasformazione in Stato democratico della
monarchia per diritto divino, un processo non promosso, ma subito dalla
Chiesa, che ha reso impraticabile il ricorso al braccio secolare. Ma la
rinuncia a qualcosa che non si possiede piu' non e' in fondo un atto
meramente retorico, e in quanto tale un po' troppo facile?
(a cura di Paolo Fezzi)
Bibliografia
Natale Benazzi e Michele D'Amico, Il Libro Nero dell'Inquisizione, Piemme,
Casale Monferrato 1998.
Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza, Einaudi, Torino 1996.
Bartolome' Bennasar, Storia dell'Inquisizione spagnola, Rizzoli, Milano
1980.
Gregory Bateson, Verso una teoria della schizofrenia in Verso un'ecologia
della mente, Adelphi, Milano 1976.
|
|
![[AmadeuX BiblioForum] [AmadeuX BiblioForum]](https://www.amadeux.it/forum/immagini/amadeuxcomm1.jpg)